"I TEMPI": CULTURA


Pillole di Storia
L' eccidio dei Romanov.
Mentre la Grande Guerra infuria, in Russia avviene qualcosa destinato a cambiare il corso del secolo. Nella terra devastata dal sanguinoso conflitto e che, rispetto alle altre potenze europee, è socialmente ed economicamente arretrata, nel marzo (febbraio per il calendario ortodosso) del 1917 scoppia la rivoluzione. I Romanov, la dinastia degli zar che regnano da secoli, verranno rovesciati dalla rivolta. Per molti mesi dunque il Paese finisce nel caos, diviso tra i partiti borghesi e quelli di sinistra, fino a quando nel novembre (ottobre, sempre secondo il calendario ortodosso) del 1917, Nikolaj Lenin, il capo del partito bolscevico, con un colpo di Stato conquista il potere e instaura una dittatura comunista destinata a durare per settant’anni. Nel luglio del 1918 - precisamente nella notte tra il 16 e il 17 - lo zar Nicola II, l’imperatrice Alessia e i loro cinque figli, l’erede Alessio, Olga, Tatiana, Maria ed Anastasia, vengono uccisi a Ekaterinenburg, dove erano tenuti prigionieri. Ma il misterioso destino di Anastasia è Storia che si farà leggenda: quella della "Principessa perduta".
18/7/2018

L'eccidio del Padule di Fucecchio
Una strage impunita.
L'eccidio del Padule di Fucecchio fu un crimine di guerra commesso da un reparto della 26ª divisione corazzata tedesca, agli ordini del generale Peter Eduard Crasemann, il 23 agosto del 1944. Nella strage persero la vita 175 civili (uomini, donne e bambini).
La strage avvenne nella vasta area pianeggiante compresa tra le province di Pistoia e Firenze, denominata Padule di Fucecchio.
Nell'estate del 1944, a causa dei bombardamenti, molte famiglie provenienti dalle province di Pistoia e Firenze lasciarono le proprie abitazioni per andare a rifugiarsi nel padule. Alcuni gruppi si unirono in bande di partigiani capeggiate dal professor Benedetti di Ponte Buggianese e si diressero verso l'interno, luogo palustre ed incolto considerato impenetrabile da parte dei tedeschi. Anche molti uomini fuggiti dai rastrellamenti nazisti nelle ore notturne raggiungevano la parte centrale, considerata più sicura. Altri gruppi di famiglie, soprattutto donne, vecchi e bambini, preferirono invece rifugiarsi nei casali e nelle capanne di pastori e contadini situate ai margini del padule.
Il 22 agosto molti soldati partirono dal villaggio diretti verso il padule; al loro ritorno, 2 giorni dopo il massacro, dichiararono di aver ucciso 200 partigiani, omettendo che in realtà il totale dei morti era composto esclusivamente da civili. Da Monsummano il 23 agosto partirono i membri del 26º Reparto Esploratori comandato dal capitano Josef Strauch, affermando di andare a combattere le bande nascoste nel padule. Intorno alle 6.00 del 23 agosto truppe tedesche si diressero verso la "Tabaccaia" dove alloggiavano molti sfollati, per lo più donne e bambini: li costrinsero ad uscire e li fucilarono sul posto. Nei dintorni altri ufficiali tedeschi fucilarono uomini che scappavano o si rifugiavano fra i campi. Tra questi ufficiali sembra che fosse presente anche il capitano Strauch. Nell'area di Ponte Buggianese vennero uccise 29 persone tra cui anche adolescenti e bambini.
I tedeschi continuarono il massacro avanzando nel padule ed uccidendo allo stesso modo altri civili indifesi. Molti altri corpi vennero trovati in altre località, uccisi allo stesso modo; in alcuni casi non ci furono testimoni superstiti, ma non c'è alcun dubbio che gli omicidi siano avvenuti per mano tedesca. Lo stesso accadde a Massarella, dove si aprì il fuoco verso il padule e, successivamente, furono trovati morti 8 uomini. In totale nella zona del Padule di Fucecchio vennero trovate 175 vittime civili probabilmente non appartenenti a bande partigiane: tra queste, molte donne e ragazzi sotto i 16 anni.
Le cause che spinsero l'esercito tedesco ad un simile atto sono incerte. Da un lato ci fu una cattiva informazione che indicò la presenza di bande di partigiani nel padule, ma durante la strage vennero uccisi solo civili innocenti. Dall'altro, contribuirono sia le direttive provenienti da Berlino, sia in particolar modo gli ordini emanati dal Feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante del Gruppo dell'Armate "C", OB Sudwest, che più di ogni altro aveva dimostrato l'intenzione di compiere una dura lotta contro le bande. Le direttive ordinavano inoltre di arrestare e trattare come prigionieri di guerra gli esponenti della resistenza, senza ucciderli. Kesselring non applicò mai l'ultima parte della direttiva, ma anzi ordinò di agire con azioni pianificate, ed in caso di attacco di aprire immediatamente il fuoco senza preoccuparsi dei passanti o di eventuali civili nei dintorni.
Nel 2012 sono stati condannati all'ergastolo due militari: la Germania non li ha mai consegnati, e nessuno, fino ad oggi, ha risarcito i familiari delle vittime.
14/7/2018

Pillole di Storia
L'attentato a Hitler.
Il successo dello sbarco alleato in Normandia - 6 giugno 1944 - e il progressivo fallimento della controffensiva tedesca degli inizi del luglio ‘44 determinano una profonda crisi all’interno della Germania. La resistenza al nazismo, formata da diversi gruppi tra i quali uno dei più noti è quello studentesco della “rosa bianca”, si fa dunque maggiormente attiva, mentre diventa palese l’insuccesso dei piani hitleriani. L’episodio più clamoroso è rappresentato dall’organizzazione di un attentato contro Hitler da parte di un gruppo di ufficiali della Wehrmarcht, il 20 luglio del 1944. L’esecutore materiale è il colonnello Klaus von Stauffenberg, un eroe di guerra, che fa esplodere un ordigno all’interno della Wolfsschanze, il quartier generale del Fuher, che però viene soltanto ferito. A capo della congiura vi sono alti ufficiali e borghesi di orientamento sia conservatore che socialista, uniti nella convinzione che il regime nazista porti la Germania alla rovina. Scampato alla morte, Hitler procede a una spietata repressione che inaugura la fase estrema del terrore interno ad opera delle S.S.
8/7/2018

Pillole di Storia
Hiroshima: il primo bombardamento atomico della Storia.
Nessun secolo come il Novecento, che pure ha visto avanzare enormi progressi, è stato così devastato da guerre ed orrori: tra questi l’atomica non può certo essere dimenticata.
La guerra, finita in Europa, continua ancora nel Pacifico, dove i giapponesi, anche se ormai alle corde, dimostrano un’incredibile capacità di resistenza. È allora che Harry Truman, diventato il Presidente degli Stati Uniti dopo la morte di Theodore Roosevelt, per costringere il governo di Tokyo ad arrendersi ordina la “soluzione finale”: la bomba atomica. Alle ore 8.15 del 6 agosto 1945 dunque, il bombardiere americano B-29 Superfortress - ribattezzato Enola Gay (dal nome della madre) dal pilota Paul Tibbets - sgancia un ordigno nucleare su Hiroshima: Little Boy, nome in codice della bomba nucleare all'uranio.
Nel terribile “fungo atomico” - una potenza esplosiva pari a 13 mila tonnellate di tritolo - perdono la vita immediatamente decine di migliaia di giapponesi, mentre moltissimi altri, esposti alle radiazioni nucleari, moriranno in seguito o subiranno terribili conseguenze. La città è praticamente rasa al suolo. Eppure, appena tre giorni dopo, un’altra bomba atomica viene sganciata dagli americani a Nagasaki, provocando una seconda catastrofe. Un'apocalisse che proseguirà con gli hibakusha, i sopravvissuti, il 20% dei quali rimarrà affetto da avvelenamento da radiazioni e da necrosi, portando il numero delle vittime a più di 200 mila (solo per Hiroshima). Il 2 settembre 1945 anche il Giappone accetterà la resa: la Seconda guerra mondiale è davvero terminata.
Contro l'orrore delle bombe atomiche si pronunceranno scienziati di fama mondiale, su tutti Albert Einstein che insieme al filosofo Bertrand Russel presenterà a Londra, nel 1955, un manifesto introdotto dalla celebre frase “Ricordatevi della vostra umanità, e dimenticate il resto”.
6/7/2018

Violet Gibson: la donna che sparò al Duce.
La storia dell’aristocratica inglese che nel 1926 tentò di uccidere Mussolini in Piazza del Campidoglio, a Roma, in mezzo alla folla.
Il 7 aprile del 1926 Benito Mussolini, dopo aver aperto con un discorso sui progressi della medicina la conferenza internazionale di chirurgia, fa ritorno in Campidoglio salutando dall’automobile scoperta la folla festante. Una piccola signora dimessa, dai capelli grigi, gli spara con una pistola francese che tiene avvolta in un velo nero. Ma il primo ministro si è voltato bruscamente verso degli studenti e la pallottola gli sfiora il naso. Violet Gibson ci riprova: la pistola si inceppa. La donna, sottratta a fatica dal tentativo di linciaggio della folla, viene subito arrestata. Il giorno dopo il duce si presenterà in visita ufficiale in Libia con il naso bendato, come mostrano diverse foto.
Ma chi era Violet Gibson? E perché sparò al Duce?
Violet Gibson era una matura signorina appartenente ad una aristocratica e ricca famiglia anglo-irlandese; il padre Edward diventò Lord Cancelliere d’Irlanda e primo barone Ashbourne. Fin da giovane dà segni di squilibrio mentale dopo la morte del promesso sposo. Insoddisfatta e sfaccendata si converte al cattolicesimo, una religione inadatta alla sua classe sociale e alle sue origini inglesi, e i genitori la mandano con la cameriera a visitare per lunghi periodi l’Italia e la Svizzera, dove segue i seminari di Rudolf Steiner, diventa pacifista e come tale viene schedata da Scotland Yard. Nei giorni dell'attentato alloggia a Roma, presso una comunità di suore, e chiede inutilmente in Vaticano un'udienza privata con il Papa. Pare che quel 7 aprile sia uscita armata con l'intenzione di attentare proprio alla vita del Pontefice e che solo per curiosità si sia poi avvicinata al Campidoglio. Spara quindi due colpi da distanza ravvicinata contro Mussolini che - come detto - avendo appena lasciato i partecipanti ad un congresso internazionale di chirurgia, ha la fortuna di essere assistito al meglio per la ferita al naso. “Certo che me la cavai per un miracolo”, avrebbe dichiarato il Duce incerottato.
Gli agenti, guidati dal questore Benedetto Bodini, responsabile della sicurezza personale di Mussolini, sottraggono dunque a fatica l'attentatrice alla violenza della folla. Violet Gibson, dichiarata non sana di mente, è rimandata al paese di origine e l'opinione pubblica inglese ne rimane molto soddisfatta.
Il fratello della donna si affretta infatti a spedire un telegramma a Mussolini subito dopo l'attentato: “La famiglia di Violet Gibson è addolorata dell'incidente ed esprime i sensi della propria simpatia”.
Prima di partire scrive una lettera alle guardie per ringraziarle dell’ospitalità, e accompagnata dalla sorella, circondata da infermiere e scortata dalla polizia viene messa su un treno per Londra.
Le indagini non furono mai in grado di chiarire il movente del gesto. La pista del complotto è stata sondata, ma non ha portato ad alcun risultato. Le dichiarazioni della Gibson furono contraddittorie e non aiutarono a risolvere il caso. Le perizie psichiatriche la dichiararono insana di mente, motivo per il quale venne chiusa per sei mesi in un manicomio di Roma, durante le indagini. Alla fine, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato dichiarò la donna incapace di intendere e di volere ed emise sentenza di non luogo a procedere. Trasferita in Inghilterra, finì in un altro ospedale psichiatrico, a Northampton, dove morì nel 1956. Sull’imprevedibile attentato, salito agli onori della cronaca nei giorni immediatamente successivi, cadde rapidamente il silenzio.
Di lì a breve però un altro attentato, ancora a Roma, cercherà di colpire il Duce.
L'11 settembre del 1926 l'anarchico carrarese ventiseienne Gino Lucetti, noto alla polizia ed emigrato in Francia per motivi politici, lancia una bomba a frammentazione contro l'automobile di Mussolini che transita a Porta Pia. L'ordigno rimbalza sulla carrozzeria ed esplode a distanza ferendo otto passanti. Lucetti per più giorni si è appostato lungo il percorso che la Lancia presidenziale compie da Villa Torlonia a Palazzo Chigi, dove Mussolini ha il suo ufficio. L'attentatore lancia anche una seconda bomba, inesplosa, contro chi lo insegue ma non usa la pistola che ha con sé. La polizia cerca invano le prove di un complotto, arresta la madre, il fratello e la sorella di Lucetti, vecchi amici carraresi e anche chi ha alloggiato con lui in albergo. Lucetti viene condannato dal Tribunale speciale a 30 anni di reclusione. Liberato dalle truppe alleate nel 1943, muore poco dopo, vittima di un bombardamento.
Ma questa è un'altra storia.
30/6/2018

La Grande Guerra
È il 28 giugno del 1914 quando alcuni colpi di pistola danno inizio al “grande massacro”.
Il 28 giugno del 1914 uno studente bosniaco - Gavrilo Princìp - uccide a Sarajevo l’erede al trono austro-ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando, e sua moglie Sofia. È il segnale d’inizio della Prima guerra mondiale: un conflitto che da anni ormai covava in Europa e che vedrà schierarsi Russia, Francia e Inghilterra da un lato, Germania e Austria-Ungheria dall’altro.
L’Italia, alleata con tedeschi e austriaci, il 24 maggio 1915 entra in guerra contro i vecchi alleati.
A terribili e sanguinose battaglie, si alterna il logorante conflitto in trincea. Ma nel 1917, mentre gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco di inglesi e francesi, gli austriaci rompono il fronte italiano.
È la disfatta di Caporetto: all’alba del 24 ottobre 1917 Luigi Cadorna, nella sede del Comando Supremo di Udine, viene informato del pesante bombardamento sulla linea Plezzo-Tolmino. Fedele alle sue convinzioni, il generale la ritiene una simulazione per distogliere l’attenzione dal fronte carsico. Contemporaneamente sul monte Krasij, a nord di Caporetto, si trova la terza linea difensiva formata da alcuni battaglioni alpini, tra cui quello comandato dal volontario interventista Carlo Emilio Gadda. Lui ed i suoi uomini vengono svegliati alle due del mattino dai bombardamenti massicci che proseguono fino all’alba. Non subendo però alcun attacco e non ricevendo alcun ordine, rimangono nelle loro posizioni, isolati e completamente avvolti nella nebbia. Verso le 12 vedono alcuni soldati italiani inseguiti da quelli austro-germanici e, alle 15, sentono le esplosioni dei ponti sull’Isonzo. Capiscono allora di essere bloccati, ed attendono con rassegnazione l’attacco nemico. Il bilancio finale è catastrofico per gli italiani: 11 mila morti, 30 mila feriti e circa 300 mila prigionieri. Il presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando rimuove pertanto Cadorna dall'incarico e lo sostituisce con il generale napoletano Armando Diaz.
Dopo Caporetto, tuttavia, l’Italia trova le risorse e la forza per rovesciare le sorti della guerra.
Il nostro esercito crea sul fiume Piave e sul monte Grappa un muro umano contro l’avanzata austriaca che, alla fine, si esaurisce.
Anche la Germania tenta il colpo finale con le grandi offensive del marzo-luglio 1918, ma alla fine viene piegata dagli americani, dagli inglesi e dai francesi, in una serie di campagne culminanti con la seconda battaglia della Marna.
Il 24 ottobre del 1918, sul fronte italiano, il generale Diaz scatena la controffensiva e, a Vittorio Veneto, dà il colpo finale agli eserciti imperiali.
Il kaiser Guglielmo II è costretto ad abbandonare il trono e a fuggire dalla Germania dove viene proclamata la repubblica. La stessa cosa accade in Austria.
Finalmente, dopo cinque anni di massacri, dopo la morte di milioni di soldati e le sofferenze di tante popolazioni, scocca l’ora della pace e folle di combattenti possono tornare dalle loro famiglie.
Ma la pace è durissima per gli sconfitti. L’impero austriaco viene smembrato, mentre sulla Germania si abbattono una serie di condizioni economiche e politiche che la metteranno in ginocchio per oltre dieci anni.
28/6/2018
Il Cinematografo: un brevetto dei fratelli Lumière.
Il 13 febbraio del 1894 i fratelli Lumière brevettarono il Cinematografo: uno strumento in grado di catturare e riprodurre immagini, unendo le proprietà di una camera da presa e di un proiettore. Con il Cinematographe la realtà per la prima volta non era più statica, ma ripresa nel suo continuo divenire. Si completava così una ricerca scientifica durata circa otto secoli. La prima dimostrazione del suo funzionamento avvenne nell'aprile del 1895 presso la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale di Parigi. Otto mesi più tardi venne presentato al pubblico al Salon Indien du Grand Café - una sala nel seminterrato dello storico locale parigino di Boulevard des Capucines, vicino alla Place de l'Opéra -. I dieci episodi di vita reali proiettati sullo schermo entusiasmarono pubblico e stampa.
Ai due geniali fratelli il III Municipio di Roma ha dedicato “Largo fratelli Lumière”.
22/6/2018

Massimo Fagioli: quando l’Analisi diventa collettiva.
La vita e “le analisi” di Massimo Fagioli (1931-2017): neuropsichiatra, scrittore, intellettuale. Fondatore di una scuola di psicanalisi basata sulla lettura dei sogni e il ritorno all’esperienza della nascita.
Nato a Monte Giberto, in provincia di Ascoli Piceno, il 19 maggio del 1931, Massimo Fagioli si è laureato all’Università “La Sapienza” di Roma in Medicina e Chirurgia, e si è specializzato a Modena in Neuropsichiatra: studi intrapresi per l’esigenza di comprendere la realtà psichica umana, oggetto di una ricerca iniziata fin dagli anni dell’adolescenza, dopo essere stato, ragazzino, nelle Marche al fianco dei partigiani nella guerra di Resistenza e del padre medico di campo.
Arriva quindi a Venezia, nell’antico manicomio dell’isola di San Clemente, dove ha il primo contatto con i malati cronici, le corsie bianche, l’elettroshock. Nelle vecchie cartelle cliniche della biblioteca scopre che due parole prevalgono nelle descrizioni del malato di mente: “stolido, anaffettivo”.
Dalle pratiche angosciose della psichiatria Ottocentesca, che cercava risposte nei vetrini di sezioni del cervello, Fagioli passa poi all’ospedale psichiatrico di Padova. Qui la prassi di una clinica raffinata e l’approccio di patologie gravi con metodi per l’epoca all’avanguardia, oltre che con l’insulinoterapia, sono l’occasione per realizzare le prime esperienze di psichiatria attiva con gruppi di malati, che il giovane medico riesce a portare fuori a passeggio in città, “abbattendo” i muri del manicomio.
La ricerca di Fagioli sulle cause della malattia mentale, agli inizi degli anni ’60, si sposta sul non cosciente e lo porta in Svizzera, nella clinica Bellevue di Binswanger a Kreuzlingen, dove dirige la comunità terapeutica di lingua italiana, convivendo notte e giorno con i pazienti senza mediazioni.
Soltanto dopo una lunga analisi personale e dieci anni circa da analista con studio medico di terapia individuale, propone nel 1971 agli ambienti scientifici il risultato delle sue esperienze e della sua formazione nel libro Istinto di morte e conoscenza, scritto nel 1970, pubblicato in una nuova edizione da L'asino d'oro nel 2010 e successivamente anche in lingua tedesca, a distanza di quarant’ anni, nel 2011, dall’editore Stroemfeld (Todestrieb und Erkenntnis).
Il libro contiene i fondamenti della Teoria della nascita, secondo la quale il pensiero umano inizia alla nascita con la reazione alla luce, attraverso la retina, del corpo del neonato: scoperte sviluppate poi con La marionetta e il burattino e Teoria della nascita e castrazione umana, del 1974, editi tra la fine dello stesso anno e il 1975.
Dal 1975 Fagioli ha risposto alla domanda di psicoterapia da parte di centinaia di persone, e si sono formati, prima all’Istituto di Psichiatria dell’Università di Roma “La Sapienza” e poi in un molto ampio studio privato a Trastevere (1980), i seminari di Analisi collettiva: una prassi di cura per la guarigione della malattia mentale basata sull’interpretazione dei sogni, che prosegue come ricerca sulla realtà umana e la sua evoluzione. Il suo quarto volume intervista, Bambino donna e trasformazione dell’uomo, è del 1979.
Fagioli ha continuato nel tempo a svolgere e approfondire i fondamenti teorici del 1970-74 in una serie di altri scritti di psichiatria e attraverso libere espressioni in ambito artistico.
Nel 1997 è regista de Il cielo della luna e poi di Mélange (1999) e di La psichiatria, esiste? (2002).
Fagioli dal 1991 ha collaborato anche con un gruppo di giovani architetti; il catalogo dei progetti, Il coraggio delle immagini, viene pubblicato nel 1994. Il palazzetto bianco, su suo disegno del 1991, è stato realizzato a Roma nel 2004-05. Nel 2008 ha partecipato all’esposizione mondiale di architettura a Torino “Architektonica”, con progetti inediti realizzati dal 1999 al 2008.
Dal 2006 Fagioli ha firmato la rubrica Trasformazione sul settimanale Left.
Alla sua opera teorica e alla sua prassi si riferisce la rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla, che nel 2012 ha celebrato venti anni dalla fondazione.
La teoria e la prassi di Massimo Fagioli hanno inoltre dato vita dal 1997 fino al 2004 agli Incontri di ricerca psichiatrica presso l’Aula magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, e dal 2002 a un corso di lezioni affollatissime di psicologia dinamica, presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”.
Autore di venti libri, pubblicati dal 2009 da L’Asino d’oro edizioni, Massimo Fagioli è stato presente con le sue opere ogni anno al Salone del Libro di Torino.
Oltre ai volumi fondamentali della Teoria della nascita (Istinto di morte e conoscenza, La marionetta e il burattino, Teoria della nascita e castrazione umana, Bambino donna e trasformazione dell’uomo), ricordiamo: Storia di una ricerca (Lezioni 2002), Una vita irrazionale (Lezioni 2006), Das Unbewusste. L’inconoscibile (Lezioni 2003), Fantasia di sparizione (Lezioni 2007), Left 2006, Left 2007, Il pensiero nuovo (Lezioni 2004), Left 2008, L’uomo nel cortile (Lezioni 2005), Left 2009, Settimo anno (Lezioni 2008), Left 2010, Religione, Ragione e Libertà (Lezioni 2009), Left 2011, L'idea della nascita umana (Lezioni 2010) e Left 2012.
Massimo Fagioli si è spento a Roma il 13 febbraio del 2017, all’età di 85 anni.
21/6/2018

Alcide De Gasperi: l'uomo della Ricostruzione.
La vita di Alcide De Gasperi (1881-1954): il pensiero e l'azione politica, economica e sociale di un grande "uomo di Stato", protagonista indiscusso della storia italiana del secondo dopoguerra.
A lui è peraltro intitolata la Scuola elementare di Via Matteo Bandello, nel quartiere Talenti del III Municipio capitolino.
Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile del 1881 a Pieve Tesino, in provincia di Trento (all'epoca provincia del Tirolo, una delle regioni dell'Impero austro-ungarico).
Nel 1900 si iscrive alla facoltà di Filosofia dell'Università di Vienna ed entra in contatto con il movimento cristiano sociale: è un fiero avversario del capitalismo liberale e del socialismo.
Nel 1911 viene eletto nel Parlamento di Vienna dove difende i diritti linguistici dei trentini, e allo scoppio della guerra contro l'Austria si schiera per la neutralità italiana. Dopo la guerra il Trentino passa all'Italia e nel maggio del 1921 De Gasperi viene eletto deputato nelle liste del Partito Popolare, che nel 1924 lo nomina segretario. L'ascesa del fascismo verso la dittatura totalitaria a partito unico lo costringe a dimettersi alla fine del 1925. Nel marzo del 1927 viene arrestato a Firenze con l'accusa di espatrio clandestino. Alla fine del lungo processo è condannato a due anni e sei mesi di reclusione: è il periodo più difficile della sua vita.
Si ammala e trascorre la detenzione in una clinica sotto sorveglianza. Vi resta fino al luglio del 1928, quando gli viene finalmente concessa la libertà vigilata, grazie all'intercessione della Santa Sede. Vive a Roma con la moglie e le figlie. Per mantenere la famiglia traduce dal tedesco e nel marzo del 1929, con l'aiuto di Mons. Montini, è assunto nella Biblioteca Vaticana dove rimane fino al crollo del regime fascista.
Dopo la guerra diviene il leader della Democrazia Cristiana e vince alle elezioni del 1948 contro il Fronte Popolare - che unisce il PSI e il PCI - guidato da Palmiro Togliatti.
Negli anni della Ricostruzione De Gasperi ha due grandi progetti: ancorare l'Italia all'Occidente e costruire un grande partito cattolico. È un autorevole uomo politico, riconosciuto dalle potenze vincitrici. Riesce ad ottenere gli aiuti del Piano Marshall per la ricostruzione dell'economia italiana e ha un ruolo di primo piano nel processo di integrazione europea, diventando uno dei padri fondatori dell'Unione europea.
Il leader democristiano si impegna quindi per creare un partito di massa che tenga insieme le diverse anime del movimento cattolico, che occupi il centro dello schieramento politico e che sia interclassista. Dopo le elezioni del 18 aprile 1948 nasce dunque la prima legislatura repubblicana e ha inizio la stagione del cosiddetto “centrismo”.
Dal 1948 al 1953 l'attività di De Gasperi è imperniata in una politica riformista che non sconvolge gli equilibri sociali e che garantisce alla DC il consenso delle masse popolari e, in modo particolare, di quelle rurali che rappresentano il suo bacino elettorale. È in questo orizzonte che il leader democristiano si batte per i provvedimenti più importanti del suo governo: la riforma agraria, l'istituzione della cassa del Mezzogiorno, il piano Fanfani per la costruzione di case popolari e la riforma tributaria.
Per rendere più stabile la coalizione governativa De Gasperi modifica la legge elettorale, in senso maggioritario, nell'imminenza delle elezioni politiche del 7 giugno 1953. Lo scopo è quello di assegnare il 65% dei seggi al partito, o al gruppo di partiti, che ottenga la metà più uno dei voti. Nelle votazioni di giugno, però, il premio di maggioranza non scatta e De Gasperi subisce la prima grande sconfitta politica. È la fine del centrismo e della sua carriera politica.
Si spegne meno di un anno dopo a Borgo Valsugana, il 19 agosto del 1954, nel Trentino diventato nel frattempo regione autonoma della Repubblica italiana.
Nel 1993 la Chiesa ha avviato in suo favore il processo di canonizzazione, riconoscendogli il titolo di “Servo di Dio”.
20/6/2018

La vita di Don Bosco: il Santo dei giovani.
La forza del suo messaggio non ha subìto i segni del tempo. Vi resiste e si perpetua rinnovandosi, rinascendo e crescendo accanto ai tanti giovani che nelle varie epoche, in una prospettiva diacronica, hanno continuato e continuano a seguire il cammino da lui tracciato.
La vita - e l’opera - di Giovanni Bosco dunque (1815-1888): il ritratto del fondatore delle Congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, profondamente radicate nel territorio del III Municipio - Parrocchia Santa Maria della Speranza, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Università Pontificia Salesiana -, canonizzato da Papa Pio XI nel 1934.
Giovanni Bosco nacque il 16 agosto del 1815 in una modesta cascina dove ora sorge il Tempio di Don Bosco, nella frazione collinare I Becchi di Castelnuovo d'Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco), figlio dei contadini Francesco Bosco e Margherita Occhiena.
Quando Giovanni aveva soltanto due anni, il padre contrasse una grave polmonite che lo condusse alla morte a soli 33 anni. Francesco Bosco lasciò così la moglie Margherita vedova con due figli da accudire (Giuseppe, nato nel 1813, e Giovanni), oltre alla madre del marito, anziana ed inferma.
Furono anni molto difficili per mamma Margherita; molta gente morì a causa della fame e delle epidemie.
A nove anni il piccolo Giovanni Bosco ebbe un sogno che egli stesso definì "profetico" e che più volte raccontò ai ragazzi del suo Oratorio[1].
Lo storico Pietro Stella ipotizzò che il sogno del giovane Bosco venne influenzato da una predica riguardante il mandato di Gesù a san Pietro e la celebre frase: «Pasci le mie pecorelle». Secondo gli studi dello storico infatti Giovanni fece quel sogno proprio la notte successiva alla festa di San Pietro.
In seguito a quel sogno, il giovane Bosco decise di seguire la strada del sacerdozio. A Capriglio vi era una scuola elementare all'interno della parrocchia in cui si recò il ragazzino per studiare ma don Lacqua, il cappellano che gestiva le lezioni, non lo accolse fra i suoi alunni poiché apparteneva a un altro Comune. Fortuna volle che, morta la serva del curato, questi assunse Marianna Occhiena, sorella di Margherita e dunque zia di Giovanni Bosco, che pregò don Lacqua affinché accogliesse il nipote a scuola. Questi accettò malvolentieri ma finì comunque per affezionarsi al ragazzo, difendendolo dai compagni che lo maltrattavano perché di un altro paese.
Per avvicinare alla preghiera e all'ascolto della messa i ragazzini del paese, Giovanni Bosco decise di imparare i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi, attirando così i coetanei e i contadini del luogo grazie a salti e trucchetti di magia, invitandoli però prima a recitare il Rosario e ad ascoltare una lettura tratta dal Vangelo.
Nel febbraio del 1826 Giovanni Bosco perse anche la nonna paterna che viveva con loro. Poiché ella riusciva a tenere a freno i tre ragazzi della famiglia, Margherita, spaventata dal fatto che il figlio potesse perdere la via giusta, chiese al parroco, don Sismondo, di concedergli la Comunione, benché l'età media dei ragazzi per accedere al sacramento fosse di dodici anni, mentre Giovannino Bosco aveva soltanto undici anni. Don Sismondo accondiscese e così il 26 marzo 1826, il ragazzo fece la sua Prima Comunione.
L'inverno che seguì per lui fu il più duro: il fratellastro Antonio, che già guardava di cattivo occhio il fatto che Giovannino frequentasse la scuola e per di più passasse il tempo pregando e compiendo giochi di prestigio, si lamentò di lui e a stento il ragazzino riuscì a salvarsi dai suoi pugni. Margherita fu così costretta a mandare via il figlio dai Becchi per farlo vivere come garzone a Moncucco Torinese presso la cascina dei coniugi Luigi e Dorotea Moglia, dove rimase dal febbraio 1827 al novembre 1829. Essi, in un primo momento, non volevano accogliere il giovane fra i propri lavoratori ma osservando la tenacia e l'intelligenza del ragazzo decisero di tenerlo con loro, affidandolo al vaccaro della famiglia, il vecchio Giuseppe, chiamato da tutti "lo zio".
Essendo desideroso di studiare, Giovanni chiese allo zio Michele Occhiena, che aveva scambi con il Seminario di Chieri, di intercedere per lui affinché qualche sacerdote accettasse di istruirlo. Michele non riuscì però ad ottenere alcun risultato. Nel settembre di quel 1829, a Morialdo era venuto a stabilirsi come cappellano don Giovanni Calosso, sacerdote settantenne; questi, dopo aver constatato quanto intelligente e desideroso di studiare fosse il giovane, decise di accoglierlo nella propria casa per insegnargli la grammatica latina e prepararlo così alla vita del sacerdote. Un anno dopo, e precisamente il 21 novembre del 1830, Giovanni Calosso fu colpito da apoplessia e moribondo diede al giovane amico la chiave della sua cassaforte, dove erano conservate seimila lire che avrebbero permesso a Giovanni di studiare ed entrare in Seminario. Il ragazzo però preferì non accettare il regalo del maestro e consegnò l'eredità ai parenti del defunto.
Il 21 marzo 1831 il fratellastro Antonio sposò Anna Rosso, di Castelnuovo, e la madre decise di dividere l'asse patrimoniale con lui così che Giovanni poté tornare a casa e riprendere da settembre gli studi a Castelnuovo con la possibilità di una semi-pensione presso Giovanni Roberto, sarto e musicista del paese che gli insegnò il proprio mestiere. A fine anno decise di andare a studiare a Chieri e l'estate la passò al Sussambrino, una cascina di Castelnuovo che suo fratello Giuseppe, insieme all'amico Giuseppe Febraro, aveva preso a mezzadria.
Grazie all'aiuto del maestro, don Emanuele Virano, riuscì a recuperare tutto il tempo perduto ma, non appena questi fu nominato parroco di Mondonio e dovette abbandonare la scuola, il suo sostituto, don Nicola Moglia, di settantacinque anni, non riuscendo a contenere i suoi giovani studenti, fece perdere al giovane Bosco tempo prezioso che egli comunque spese imparando diversi mestieri, quale quello del sarto, grazie all'aiuto di Giovanni Roberto e quello del fabbro nella fucina di Evasio Savio, un suo amico. Proprio con gli insegnamenti di quest’ultimo, egli un giorno sarebbe riuscito a fondare laboratori per i ragazzi dell'Oratorio di Valdocco.
A Chieri si stabilì a pensione presso la casa di Lucia Matta. Per mantenersi gli studi lavorò come garzone, cameriere, addetto alla stalla. Qui fondò la Società dell'Allegria, attraverso la quale, in compagnia di alcuni giovani di buona fede, tentava di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso i suoi soliti giochi di prestigio e i suoi numeri acrobatici. Egli stesso raccontava che un giorno riuscì a battere un saltimbanco professionista, acquistandosi così il rispetto degli altri e la loro considerazione.
Durante gli anni di studio, Giovanni Bosco strinse forte amicizia con Luigi Comollo, nipote del parroco di Cinzano. Il giovane era spesso maltrattato dai suoi compagni, insultato e picchiato ma accettava spesso con un sorriso o una parola di perdono queste sofferenze. Il giovane Bosco, dal canto suo, non sopportava di vedere il coetaneo così maltrattato e spesso lo difendeva azzuffandosi con i suoi aggressori.
Le parole di Comollo e le sue incessanti preghiere turbarono profondamente l'animo di Giovanni tanto che egli stesso un giorno ricordò nelle sue Memorie: "Posso dire che da lui ho cominciato a imparare a vivere da cristiano". Grazie al suo atteggiamento così mansueto e innocente, il futuro santo comprese quanto fosse importante per lui raggiungere la salvezza dell'anima e ciò rimase talmente impresso nella sua mente che un giorno, quando egli avrebbe fondato l'Oratorio a Valdocco, avrebbe trascritto su un cartello nella propria stanza: «Toglimi tutto, ma dammi le anime»
Nell'autunno del 1832, Giovanni Bosco iniziò la terza grammatica. Nei due anni seguenti proseguì regolarmente frequentando le classi che venivano chiamate umanità (1833-34) e retorica (1834-35), dimostrandosi un allievo eccellente, appassionato dei libri e di grande memoria.
Nel marzo 1834 Giovanni Bosco, che si avviava a terminare l'anno di umanità, presentò ai Francescani la domanda di essere accettato nel loro ordine ma cambiò idea prima di andare in convento, seguendo un sogno misterioso sulla cosa ed il consiglio diretto di don Giuseppe Cafasso. Decise allora di vestire l'abito clericale entrando in seminario. Il giovane prete don Giuseppe Cafasso gli consigliò di completare l'anno di retorica e quindi di presentarsi all'esame per entrare al seminario di Chieri, aperto nel 1829. Giovanni superò l'esame, che si tenne a Torino, il 25 ottobre prese l'abito ecclesiastico e il 30 ottobre 1835 si presentò in seminario.
Il 3 novembre 1837 Giovanni iniziò la teologia, studio fondamentale per gli aspiranti al sacerdozio. In quel tempo occupava cinque anni, e comprendeva come materie principali la dogmatica (lo studio delle verità cristiane), la morale (la legge che il cristiano deve osservare), la Sacra Scrittura (la parola di Dio), la storia ecclesiastica (storia della Chiesa dalle origini del cristianesimo all'età contemporanea).
In seminario Giovanni Bosco rincontrò l'amico Comollo con il quale poté così ristabilire la salda amicizia di un tempo. Ma il 2 aprile del 1837, Luigi Comollo, già debole fisicamente, cadde malato e si spense a soli 22 anni. Nella notte dal 3 al 4 aprile, notte che seguiva il giorno della sua sepoltura, secondo una testimonianza diretta di Giovanni Bosco e dei suoi venti compagni di camera, alunni del corso teologico, l'amico defunto apparve loro sotto forma di una luce che, per tre volte consecutive, disse: "Bosco! Bosco! Bosco! Io sono salvo!". A ricordo dell'evento fu posta una lapide in un corridoio nel Seminario di Chieri. Il giovane chierico da quel momento in poi decise di "mettere la salvezza eterna al di sopra di tutto, a considerarla come l'unica cosa veramente importante". Il suo motto, ispirato a Gn 14,21, che richiudeva il suo programma di vita, fu sempre: "Da mihi animas, coetera tolle" (Dammi le anime, prenditi tutto il resto), scritto a grossi caratteri su un cartello, che teneva nella sua stanza.
Il 29 marzo 1841 ricevette l'ordine del diaconato, il 26 maggio iniziò gli esercizi spirituali di preparazione al sacerdozio che ricevette il 5 giugno 1841 nella Cappella dell'Arcivescovado di Torino.
Diventato prete, ricevette alcune proposte lavorative da parte di amici e conoscenti che, per ricompensare lui e la sua famiglia dei sacrifici fatti, lo volevano come istitutore a Genova o come cappellano. Egli però si rifiutò di accettare tali funzioni sia per una propria inclinazione all'umiltà, sia per le accese omelie di Giuseppe Cafasso, che accusava i sacerdoti di ingordigia e avidità, sia per la perentoria affermazione della madre Margherita: "Se per sventura diventerai ricco, non metterò mai più piede a casa tua".
Su invito del Cafasso, decise di entrare, ai primi di novembre del 1841, in Convitto a Torino, un ex-convento accanto alla chiesa di San Francesco di Assisi. In questo edificio il teologo Luigi Guala, aiutato dal già citato Cafasso, preparava 45 giovani sacerdoti a diventare preti del tempo e della società in cui dovranno vivere. La preparazione durò tre anni.
Ispirato dalle notizie riguardanti don Giovanni Cocchi, che pochi anni prima di lui aveva tentato di radunare all'interno di un Oratorio i ragazzi disagiati di Torino, Giovanni Bosco decise di scendere per le strade della sua città e osservare in quale stato di degrado fossero i giovani del tempo. Incontrò così i ragazzi che, sulla piazza di Porta Palazzo, cercavano in tutte le maniere di procurarsi un lavoro. Di questi giovani molti erano scartati perché poco robusti e in poco tempo costretti a finire presto sottoterra. Le statistiche confermano che in quel tempo ben 7184 fanciulli sotto i dieci anni erano impiegati nelle fabbriche.
In piazza San Carlo, Don Bosco poteva conversare con i piccoli spazzacamini, di circa sette o otto anni, che gli raccontavano il loro mestiere e i problemi da esso generati. Erano molto rispettosi nei confronti del sacerdote che li difendeva molto spesso contro i soprusi dei lavoratori più grandi che tentavano di derubarli del misero stipendio.
Insieme a don Cafasso cominciò a visitare anche le carceri e inorridì di fronte al degrado nel quale vivevano giovani dai 12 ai 18 anni, rosicchiati dagli insetti e desiderosi di mangiare anche un misero tozzo di pane. Dopo diversi giorni di antagonismo, i carcerati decisero di avvicinarsi al sacerdote, raccontandogli le loro vite e i loro tormenti. Don Bosco sapeva che quei ragazzi sarebbero andati alla rovina senza una guida e quindi si fece promettere che, non appena essi fossero usciti di galera, lo avrebbero raggiunto alla chiesa di San Francesco.
L'8 dicembre 1841 incontrò, prima di celebrare Messa, Bartolomeo Garelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi. Questi fu il primo ragazzo che si unì al suo gruppo. Don Bosco aveva deciso così di radunare intorno a sé tutti i ragazzi degradati della zona, dai piccoli spazzacamini agli ex detenuti. Fondamenti della sua futura attività erano tre: l'amicizia con i giovani (che molto spesso erano orfani senza famiglia), l'istruzione e l'avvicinamento alla Chiesa. La sera di quello stesso giorno, Giovanni fece amicizia anche con i tre fratelli Buzzetti, provenienti da Caronno Varesino, che si erano addormentati durante la sua predica.
Quattro giorni dopo, durante la messa domenicale, erano presenti Bartolomeo Garelli insieme a un nutrito gruppo di amici e i fratelli Buzzetti, con seguito di compaesani. Quello sarebbe stato il primitivo gruppo che avrebbe dato il via all'Oratorio di Don Bosco. Già poco tempo dopo il gruppo era talmente numeroso che il sacerdote chiese l'assistenza di tre giovani preti: don Carpano, don Ponte, don Trivero. Anche alcuni ragazzi di media cultura si avvicinarono a Don Bosco, aiutandolo a tenere a bada i ragazzi più impulsivi e ribelli.
Nella primavera del 1842, al ritorno dal paese, i fratelli Buzzetti conducevano con loro il più piccolo, Giuseppe, che si affezionò molto a Don Bosco e decise, in età adulta, di seguire la via del sacerdozio, divenendo così suo braccio destro nella gestione del futuro ordine salesiano.
La relazione tra Bosco e gli ambienti protestanti torinesi furono sempre molto dure. Dapprima egli si limitò a difendere le dottrine cattoliche ed attaccare quelle protestanti. Nel 1859 arrivò addirittura al punto di bruciare pubblicamente libri protestanti, tra cui la Bibbia stessa, nell'edizione Diodati, ossia l'edizione utilizzata dai protestanti italiani.
Buoni furono i rapporti con Davide Lazzaretti, che fu ospitato a Valdocco per alcune settimane e fu difeso da Don Bosco quando venne arrestato per vagabondaggio, truffa e cospirazione politica. Tuttavia questo avvene alcuni anni prima che il Lazzaretti si autoprocalamasse "Cristo Duca e Giudice" e fondatore della dottrina millenaristica del Giurisdavidismo.
Nell'autunno del 1844 don Giuseppe Cafasso comunicò a Don Bosco di preparare le valigie poiché avevano stabilito che divenisse il direttore dell'Ospedale di Santa Filomena. Don Cafasso voleva infatti che il giovane amico facesse conoscenza con don Giovanni Borel, sacerdote legato al Re stesso, che avrebbe potuto aiutarlo economicamente nella gestione dell'Oratorio. Egli sarebbe divenuto in seguito il direttore ufficiale di tale associazione.
Il 12 aprile 1846, giorno di Pasqua, finalmente Don Bosco trovò un posto per i suoi ragazzi, una tettoia con un pezzo di prato: la tettoia Pinardi a Valdocco.
Nel 1854 diede inizio alla Società Salesiana, con la quale assicurò la stabilità delle sue opere e del suo spirito anche per gli anni futuri. Dieci anni dopo pone la prima pietra del santuario di Maria Ausiliatrice.
Nel 1872, con santa Maria Domenica Mazzarello, fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con lo scopo di educare, con il medesimo spirito, la gioventù femminile.
In quegli anni molti collegi e istituti scolastici decentrati, di stampo salesiano, furono fondati in Piemonte, come ad esempio il prestigioso collegio San Carlo a Borgo San Martino vicino Alessandria.
Nel 1875 partì la prima spedizione missionaria per l'Argentina, terra della grande emigrazione italiana dell'Ottocento. Don Bosco fondò intanto i Cooperatori, considerati da Don Bosco stesso come i «Salesiani Esterni». La presenza dei missionari era stata richiesta dall'arcivescovo, Mons. Aneiros. Informato dal console argentino Giovanni Battista Gazzolo sul lavoro dei Salesiani, propose a Don Bosco di accettare la gestione di una parrocchia a Buenos Aires ed un collegio di ragazzi a San Nicolás de los Arroyos. Don Bosco accolse la richiesta. Con una solenne celebrazione nella Basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino, l’11 novembre 1875, prese avvio la prima spedizione missionaria salesiana. Guidati da don Giovanni Cagliero, i missionari di Don Bosco si imbarcarono dal porto di Genova il 14 novembre 1875. A Buenos Aires si insediarono in una parrocchia per emigrati italiani.
La seconda spedizione, giusto un anno dopo, il 14 novembre 1876, portò a sbarcare un altro gruppo di salesiani. Li guidava don Francesco Bodrato. Con loro venne aperta, sempre a Buenos Aires, una scuola di arte e mestieri, dove si formavano sarti, falegnami, legatori. Altro personale arrivò con la terza spedizione missionaria nel 1877. Questa volta, insieme ai Salesiani, arrivarono le prime Figlie di Maria Ausiliatrice, guidate da Suor Angela Vallese.
Il sogno di Don Bosco per l'Argentina mirava tuttavia alla Patagonia. Dopo anni di attesa, nel 1879 si presentò l'occasione. Il Governo argentino affidò al generale Julio Argentino Roca la spedizione militare il cui obiettivo era la “conquista del deserto”. Mons. Espinosa, vicario di Buenos Aires, e i salesiani don Giacomo Castamagna e il chierico Botta accompagnarono l'esercito come cappellani. Venne così avviata la missione in Patagonia. Carmen de Patagones la prima opera salesiana. Più tardi venne aperta Chos Malal, quindi Bahía Blanca, Junín de los Andes e gradualmente le altre case.
Grandi missionari, come don Milanesio e don Fagnano, dedicarono impegno e creatività pastorale a questa generosa terra e ai suoi abitanti, soprattutto gli indio delle pampa. Nel 1884 don Cagliero venne nominato vicario apostolico della Patagonia settentrionale e centrale e ricevette la consacrazione episcopale il 7 dicembre dello stesso anno. L'azione missionaria sognata da Don Bosco cominciava a dare i suoi frutti ecclesiali. L'importanza dei salesiani nella cultura del paese sudamericano è testimoniata indirettamente dal tango "Cambalache" ("bottega di rigattiere"), scritto e musicato nel 1934 da Enrique Santos Discepolo. Il testo, nonostante il pessimismo di fondo dell'autore, accosta Don Bosco a figure positive come lo sportivo Primo Carnera e l'eroe nazionale argentino José de San Martín.
Dopo gli inizi, comprensibilmente faticosi, con l'entusiasmo crebbe anche la consistenza dei figli di Don Bosco in Argentina. Al lavoro in questa terra sono tanti i Salesiani che hanno legato il loro nome scrivendo pagine straordinarie di evangelizzazione e promozione umana: tra gli altri don Domenico Milanesio, don Giuseppe Vespignani, don Alberto De Agostini, Mons. Giuseppe Fagnano, don Luigi Costamagna, il tedesco don Mattia Saxler, e gli argentini don Stefano Pagliere e don Luigi Pedemonte.
Una presenza stupenda è stata quella di Artemide Zatti, giovane emigrato italiano che in Argentina diventa salesiano, svolge un lavoro umile e prezioso come infermiere, condisce di profonda spiritualità e di carità la sua giornata, muore considerato da tutti un Santo. Nell'aprile 2002 la Chiesa lo proclama “Beato”: festa e generoso impegno in tutto il mondo salesiano argentino. Sul versante educativo la Patagonia argentina ha prodotto due figure giovanili che hanno raggiunto vertici di santità: Ceferino Namuncurá (figlio del grande Cacico Manuel) e Laura Vicuña (allieva delle FMA morta tredicenne a Junín de Los Andes). Avviata la causa di beatificazione di entrambi: Laura è stata proclamata “Beata” dal Papa il 3 settembre 1988 al Colle don Bosco.
Altra figura significativa è quella di D. Juan E. Vecchi: grande maestro di Pastorale Giovanile, è stato l'ottavo successore di Don Bosco. Oggi la presenza salesiana è diffusa su tutto il territorio argentino (da Buenos Aires a Bahía Blanca, da Córdoba a Rosario, da San Miguel de Tucumán a La Plata) attraverso 2 Ispettorie con oltre 120 opere animate da un migliaio di Salesiani (in gran parte argentini).
Don Bosco si spense a Torino il 31 gennaio del 1888 ed il suo corpo è attualmente esposto all'interno di un'urna nel Santuario di Maria Ausiliatrice, in una cappella in fondo alla navata destra. Il messaggio educativo si condensò attorno a tre parole: ragione, religione, amorevolezza. Alla base del suo sistema preventivo ci fu un profondo amore per i giovani, chiave di tutta la sua opera educativa.
Il 2 giugno 1929 Pio XI lo beatificò, dichiarandolo Santo il 1º aprile 1934, giorno di Pasqua. Inoltre il 31 gennaio 1958 Pio XII, su proposta del Ministro del Lavoro, lo dichiarò “patrono degli apprendisti italiani, dei giocolieri e dei saltimbanchi”.
Tra le opere pittoriche raffiguranti San Giovanni Bosco la più conosciuta e divulgata, anche sotto forma di santino, è quella del pittore Luigi Cima, custodita nella chiesa di San Rocco a Belluno.
[1] A nove anni ebbe un sogno profetico: gli sembrò di essere in mezzo a una moltitudine di fanciulli intenti a giocare, alcuni dei quali, però, bestemmiavano. Subito Giovanni si gettò sui bestemmiatori con pugni e calci per farli tacere; ma ecco farsi avanti un Personaggio che gli dice: "Non con le percosse, ma con la bontà e l'amore dovrai guadagnare questi tuoi amici. Io ti darò la Maestra sotto la cui guida puoi divenire sapiente, e senza la quale, ogni sapienza diviene stoltezza". Il personaggio era Gesù e la Maestra Maria Santissima, alla cui guida si abbandonò per tutta la vita e che onorò con il titolo di "Ausiliatrice dei cristiani". Fu così che Giovanni volle imparare a fare il saltimbanco, il prestigiatore, il cantore, il giocoliere, per poter attirare a sé i compagni e tenerli lontani dal peccato. "Se stanno con me, diceva alla mamma, non parlano male".
19/6/2018

1849: Storia della Repubblica romana.
La Repubblica Romana del 1849 rappresenta uno degli episodi fondativi della vicenda storica nazionale e il regime politico più avanzato del Risorgimento italiano. Con essa infatti Roma diventa il simbolo, la promessa di un’Italia libera, unita e democratica. Ricostruiamo dunque il contesto e i protagonisti di quel periodo e di quei giorni cruciali.
Dopo l’estate del 1848, mentre la rivoluzione si esauriva nell’Italia meridionale, una forte ripresa democratica aveva luogo nel resto del Paese. In Toscana, dove l’idea mazziniana della Costituente italiana fu lanciata dal professore universitario e socialista moderato Giuseppe Montanelli, la pressione democratica, che era particolarmente forte nella città di Livorno, costrinse il granduca Leopoldo II a formare un nuovo governo capeggiato da Domenico Guerrazzi, letterato, anch’egli mazziniano, e dallo stesso Montanelli. A Roma, il 15 novembre fu ucciso il presidente del consiglio Pellegrino Rossi, un moderato che era stato ambasciatore di Luigi Filippo. Le agitazioni che seguirono a questo episodio indussero il papa Pio IX ad abbandonare il suo Stato e a rifugiarsi a Gaeta, dove fu raggiunto in seguito anche dal granduca di Toscana. I democratici organizzarono allora l’elezione di una Assemblea costituente, che il 9 febbraio del 1849 proclamò la fine del potere temporale e l’istituzione della repubblica.
Il potere fu affidato a un triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Secondo il disegno di Mazzini, le due regioni democratiche avrebbero dovuto dare l’esempio di superamento dello spirito municipalistico unendosi in un solo Stato repubblicano e democratico. Ma le tendenze municipalistiche nel campo democratico non erano meno forti che in quello moderato, e altrettanto paralizzante era il timore che le rivendicazioni popolari finissero con il prevalere sull’impostazione politica che i democratici intendevano dare alla loro lotta.
Intanto l’ondata democratica raggiunse anche il regno sabaudo dove la reazione contro il moderatismo, suscitata dalla sconfitta, spinse Vincenzo Gioberti ad avvicinarsi alle correnti democratiche. Fattosi portavoce delle critiche nei confronti del municipalismo piemontese, egli ottenne nel dicembre del ’48 la presidenza del Consiglio, incarico che mantenne solo per due mesi. Il suo atteggiamento ambiguo - che si rivelò particolarmente nel progetto di intervento armato in Toscana e a Roma per restaurare i sovrani spodestati - gli fece perdere ben presto sia l’appoggio dei democratici che il consenso della corte.
Al ministero Gioberti seguì un ministero Chiodo-Rattazzi, sotto il quale fu decisa la ripresa della guerra contro l’Austria. Il comando dell’esercito fu affidato al generale polacco Chrzanowski, fatto che di per sé era una prova delle difficoltà politiche e militari in cui la nuova impresa veniva avviata. Voluta dai democratici, la ripresa della guerra avveniva in un momento politico del tutto sfavorevole sia all’interno che sul piano internazionale, ed ebbe quindi rapidamente un esito negativo.
L’esercito sabaudo subì a Novara un’irrimediabile sconfitta il 23 marzo ‘49. Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II, nella speranza che questi potesse ottenere migliori condizioni nelle trattative di pace. Le clausole dell’armistizio, firmato a Vignale il 24 marzo, non comportarono perdite territoriali per il regno di Sardegna. In Toscana, i grandi proprietari moderati e il clero, facendo leva su un’ondata di sanfedismo contadino rovesciarono il governo democratico e aprirono le porte a un corpo di spedizione austriaco che occupò Livorno; favorirono inoltre il ritorno del granduca.
In un quadro politico dominato dalla ripresa reazionaria, soltanto Roma e Venezia mantenevano viva la fiamma della rivoluzione. La loro resistenza, che non poteva certo rovesciare il corso degli avvenimenti, doveva riacquistare un grande significato come riaffermazione di valori ideali e politici destinati a sopravvivere alla sconfitta. Particolarmente significativa, sotto questo aspetto, l’opera che i democratici condussero a Roma nel breve periodo di esistenza della repubblica; opera che fu il frutto della collaborazione di patrioti di tutte le regioni e che anche per questo aspetto rappresenta il momento più alto del patriottismo rivoluzionario Quarantottesco.
Il presidente della repubblica francese, Luigi Bonaparte, si assunse il compito di riportare con la forza Pio IX sul trono. Egli era spinto a questo passo dalla necessità di assicurarsi l’appoggio politico dei clericali francesi per liquidare definitivamente l’opposizione repubblicana e le residue diffidenze dei legittimisti.
Il corpo di spedizione francese, comandato dal generale Oudinot, sbarcò a Civitavecchia il 24 aprile 1849. Sotto le mura di Roma incontrò una resistenza inaspettata e fu battuto a Porta San Pancrazio dalle truppe comandate da Giuseppe Garibaldi. Fu quindi stipulata una tregua, durante la quale Garibaldi sconfisse un contingente borbonico a Palestrina e a Velletri. Il periodo di tregua non era ancora terminato quando Oudinot attaccò nuovamente di sorpresa le difese romane, fra il 2 e il 3 giugno; ma soltanto un mese dopo i francesi riuscirono ad infrangere la tenace resistenza delle milizie romane sostenute dalla popolazione, che diedero splendidi esempi di eroismo negli scontri del Vascello e del Casino dei Quattro Venti.
Il 1° luglio ’49 l’Assemblea costituente riconobbe l’impossibilità di resistere oltre, e nello stesso tempo decise di promulgare, all’atto del suo scioglimento e mentre le truppe francesi entravano vittoriose nella città, la nuova costituzione.
La tenacia con cui la repubblica aveva resistito all’attacco francese non può essere spiegata soltanto con l’entusiasmo dei patrioti e con l’abilità dei capi militari, come Giuseppe Garibaldi e l’esule napoletano Carlo Pisacane. Furono soprattutto l’azione politica di Mazzini - che in quella occasione rivelò notevoli doti di statista - e il suo spirito democratico a creare attorno ai dirigenti della repubblica un largo consenso popolare.
La costituzione romana era l’unica in Italia che prevedesse il suffragio universale; e il triumvirato romano fu il solo governo italiano che avesse cercato, durante l’anno della rivoluzione, di venire incontro ai bisogni delle masse popolari delle campagne, con l’emanazione di un decreto che stabiliva la concessione ai contadini poveri delle terre espropriate agli enti ecclesiastici. Quest’ultimo provvedimento, adottato nel febbraio del 1849, avrebbe dato - se le circostanze ne avessero permessa la realizzazione - una scossa profonda alla struttura agraria arretrata e latifondista della campagna romana.
Una volta decisa la capitolazione, i capi democratici abbandonarono la città. Garibaldi, con alcune centinaia di volontari, cercò inutilmente di portare soccorso a Venezia che ancora resisteva all’assedio austriaco - le trattative per la resa veneziana furono concluse il 26 agosto -. Mazzini lasciò Roma il 5 luglio, lanciando un proclama in cui riaffermava che la repubblica era nata dalla libera e spontanea volontà dei cittadini romani.
18/6/2018

La repubblica della Val d’Ossola: storia di una piccola utopia.
La storia della piccola repubblica partigiana della Val d’Ossola, che si è consumata nell’autunno del 1944 sulle montagne piemontesi - e alla quale è dedicata una via nel quartiere Montesacro di Roma -, ha espresso la capacità di organizzazione politica del movimento italiano di Liberazione attraverso l’esperienza delle cosiddette “zone libere”.
In base ad alcuni rapporti redatti dallo storico antifascista Riccardo Bauer (1896-1982) per il CLNAI - Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia -, gli alleati elaborarono già nel luglio del 1944 un progetto, chiamato poi “Morandi”, per far “occupare” stabilmente la Val d’Ossola e la Valle d’Aosta da parte di formazioni partigiane. In queste zone erano concentrate “forze cospicue, italiane e alleate” per assicurare “l’occupazione permanente” e attuare quindi “il piano di lotta schierata” contro i tedeschi. Molto probabilmente il Comando alleato abbandonò in seguito questa idea a causa del progressivo consolidarsi delle truppe tedesche sui capisaldi della “linea Gotica”.
Nei confronti della nostra Resistenza, alle motivazioni di carattere bellico si aggiunsero inoltre ragioni politiche. In primis, la suddivisione dell’Europa nelle “zone d’influenza” anglo-americana e sovietica; in secundis, gli Alleati non vollero un esercito partigiano italiano, bensì semplici squadre di sabotatori e di disturbo alle spalle dei tedeschi.
Nel frattempo, indipendentemente dalle intese fra gli Alleati e il CLNAI, nell’Ossola i comandanti “patrioti” Dionigi Superti, Alfredo Di Dio e il colonnello Moneta formularono un piano analogo per la liberazione della valle. Le formazioni partigiane, con un’azione fortunata contro le truppe tedesche e fasciste, riuscirono infatti a liberare tutta la vallata entrando a Domodossola la mattina del 10 settembre 1944.
Si trattò in realtà di un pugno di uomini ripartiti nelle divisioni “Valdossola”, “Valtoce” e “Piave”, che indussero alla resa i distaccamenti tedeschi e fascisti nonostante fossero molto superiori sia numericamente sia come livello di armamenti. Tuttavia, ciò che compromise maggiormente la difesa del territorio fu proprio la mancanza di armi e munizioni. Eppure anche senza gli aiuti militari promessi ripetutamente dagli Alleati, i partigiani tennero testa alle truppe nazi-fasciste per oltre un mese. E nella giornata del 12 ottobre si verificò la rottura del fronte.
Ma dopo alcuni giorni in Val Formazza, dove si cercò di organizzare un’ultima resistenza, fra il 22 e il 23 ottobre 1944 i “patrioti” furono costretti a passare il confine. Si è calcolato che oltre 20.000 persone “compromesse” dovettero riparare nel “territorio amico”. Questo numero, estremamente significativo, sta dunque ad indicare la larga partecipazione popolare alla vita della “libera” repubblica Ossolana, che ebbe pertanto una durata di sole sei settimane, ricche però di risultati e di prospettive per il futuro.
17/6/2018

Una mattina d’agosto: la strage di Sant’Anna di Stazzema.
Nell’agosto del 1944 la ferocia degli occupanti nazifascisti si scatena contro la popolazione di Sant’Anna di Stazzema - frazione del Comune di Stazzema (LU), a cui è dedicata una via nel quartiere Nuovo Salario del III Municipio di Roma - nel premeditato e deliberato tentativo di indebolire le formazioni partigiane. Quattro divisioni delle SS, accompagnate da collaborazionisti italiani, massacrano 560 civili inermi.
La strage di Sant’Anna di Stazzema suscita ancora oggi un senso di sgomento e di profonda desolazione civile e morale, poiché rappresenta una delle pagine più brutali della barbarie nazifascista. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla cronaca di quei drammatici giorni.
I primi di agosto del 1944 Sant’Anna di Stazzema viene classificata dal comando tedesco come “zona bianca”, ovvero una località adatta ad accogliere sfollati: per questo motivo la popolazione durante quell’estate supera le mille unità. Inoltre, sempre in quei giorni i partigiani abbandonano la zona senza svolgere operazioni militari di particolare entità contro i tedeschi.
Tuttavia, all’alba del 12 agosto ’44 tre reparti delle SS salgono a Sant’Anna, mentre un quarto chiude ogni via di fuga a valle. Alle sette il paese è circondato. Quando le SS arrivano a Sant’Anna, accompagnate da fascisti collaborazionisti che fanno da guide, gli uomini del paese si rifugiano nei boschi per non essere deportati, mentre donne vecchi e bambini, sicuri che nulla può succedergli in quanto civili inermi, restano nelle loro case. In poco più di tre ore vengono massacrati 560 innocenti, in gran parte bambini, donne e anziani. I nazisti li rastrellano, li chiudono nelle stalle o nelle cucine delle case, li uccidono con colpi di mitra e bombe a mano, compiendo atti di efferata barbarie. Infine il fuoco, per distruggere e cancellare tutto.
Non è stata una rappresaglia, tantomeno una vendetta. Come è emerso dalle indagini della Procura Militare di La Spezia, si è trattato di un atto terroristico, di una azione premeditata e curata in ogni minimo dettaglio. Obiettivo: radere al suolo il paese e sterminare la popolazione per rompere ogni collegamento fra le popolazioni civili e le formazioni partigiane presenti nella zona.
La ricostruzione dei fatti, l’attribuzione delle responsabilità e l’individuazione delle motivazioni che hanno provocato l’eccidio sono state possibili grazie al processo che si è svolto nel 2004 presso il Tribunale Militare di La Spezia, e che si è concluso nel 2005 con la condanna all’ergastolo per dieci ex SS colpevoli del massacro. Sentenza confermata in appello l’anno seguente e ratificata in cassazione nel 2007. Da notare che nella prima fase processuale si è sviluppato un importante lavoro investigativo, a cui sono seguite le testimonianze in aula dei superstiti e dei periti, oltre a due SS appartenute al battaglione incriminato della strage. Va sottolineata poi la scoperta, avvenuta a Roma nel 1994 negli scantinati di Palazzo Cesi, di un armadio chiuso e girato con le ante verso il muro - ribattezzato in seguito “Armadio della Vergogna” -, che ha occultato per oltre 40 anni documenti ritenuti fondamentali per la ricerca della verità storica e giudiziaria sulle stragi nazifasciste in Italia nel secondo dopoguerra.
17/6/2018
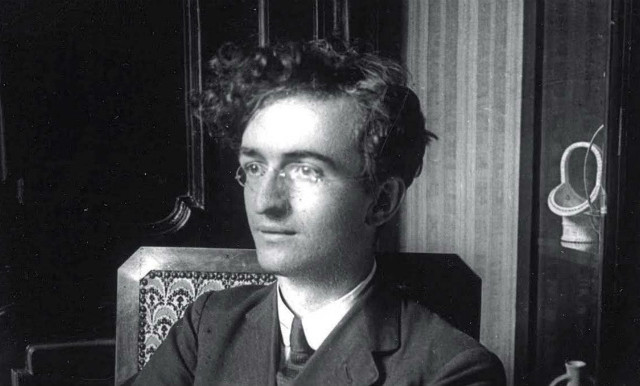
Piero Gobetti: per una "Rivoluzione Liberale".
Saggista e autore di numerosi scritti culturali e politici pubblicati in Italia e all’estero, Piero Gobetti (1901-1926) fu un simbolo del liberalismo progressista sensibile al riscatto delle classi lavoratrici. Ripercorriamo le fasi salienti della sua breve ma intensa esistenza.
Nato a Torino il 19 giugno del 1901, Piero Gobetti dopo le scuole elementari frequentò il liceo-ginnasio “Gioberti” e lì conobbe Ada Prospero - figlia di un commerciante come lui - che diventerà sua moglie. Studente universitario di acuta intelligenza, pubblicò a soli diciassette anni la sua prima rivista, “Energie Nove”, ricca di riferimenti a Giuseppe Prezzolini, Giovanni Gentile, Benedetto Croce e con la quale diffuse le idee liberali di Luigi Einaudi.
Si appassionò ai bolscevichi, studiò il russo e scrisse in cirillico alla fidanzata. Definì subito il fascismo “movimento plebeo e liberticida”, l’antifascismo “nobiltà dello spirito”, l'Italia un Paese senza un vero Risorgimento, una Riforma protestante, una Rivoluzione liberale. Interpretò la rivoluzione di Lenin e Trotzky come rivoluzione liberale, in quanto azione, movimento, e tutto quello che si muove - secondo il pensiero di Gobetti - va verso il liberalismo. Apprezzò i bolscevichi come élite, detestò lo statalismo e il protezionismo della vecchia Italia giolittiana. Fu esponente della sinistra liberale progressista, strettamente collegata con l'intellettuale meridionalista Gaetano Salvemini.
Estimatore di Antonio Gramsci e del giornale socialista e poi comunista”Ordine Nuovo”, Gobetti si avvicinò al proletariato torinese, divenendo attivo antifascista. Nel maggio del 1919 venne bollato da Palmiro Togliatti sulle pagine di “Ordine Nuovo” come "parassita della cultura". Ma nell'autunno del 1920 il sostegno di Gobetti all'occupazione delle fabbriche e i suoi frequenti incontri con gli operai e comunisti torinesi migliorarono molto i rapporti, tanto che Antonio Gramsci gli affidò la rubrica di teatro della rivista.
La classe operaia, in particolare quella torinese dei consigli di fabbrica, che frequentò insieme ai socialisti di “Ordine Nuovo”, diventò per lui la leva che innoverà il mondo: non verso il socialismo, ma verso "elementi di concorrenza". Togliatti non lo amò, Gramsci lo apprezzò, i liberali Salvemini e Croce furono incuriositi dall'intelligenza del ragazzo.
Il 12 febbraio del 1922 fece uscire il primo numero della rivista "La Rivoluzione Liberale" che via via diventò centro di impegno antifascista di segno liberale, collegato ad altri nuclei liberali di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Vi collaborarono intellettuali di diversa estrazione, tra cui Amendola, Salvatorelli, Fortunato, Gramsci, Antonicelli e Sturzo.
Più volte arrestato nel 1923-24 dalla polizia fascista, la sua rivista venne ripetutamente sequestrata. Lo stesso Mussolini si interessò di lui e telegrafò al prefetto di Torino: "Prego informarsi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore".
Nel 1924 fondò la rivista letteraria "Il Baretti", alla quale collaborarono Benedetto Croce, Eugenio Montale, Natalino Sapegno, Umberto Saba ed Emilio Cecchi. Il 5 settembre del '24, mentre stava uscendo di casa, venne aggredito sulle scale da quattro squadristi che lo colpirono al torace e al volto, rompendogli gli occhiali e procurandogli gravi ferite invalidanti. Costretto ad espatriare in Francia - mai più riavutosi dalle ferite - si spense esule a Parigi nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 1926. Il 19 giugno di quell'anno avrebbe compiuto 25 anni.
È sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.
La sua opera fu raccolta e pubblicata postuma: Opere critiche (1926); Paradosso dello spirito russo (1926); Risorgimento senza eroi (1926).
15/6/2018

Le donne del regime: la condizione femminile durante il Ventennio.
Chi sono le donne di Mussolini? Mogli, amanti, figlie, “libere unioni”? In tante godono dei frettolosi favori del Duce: Ida Dalser - morta in un manicomio - Margherita Sarfatti, donna Rachele, Claretta Petacci e molte altre. Donne importanti e tragiche.
E quale è il rapporto tra il regime fascista e la donna?
Secondo la tradizione la donna è relegata in secondo piano: madre prolifica - nel 1927 inizia la grande la battaglia per l’aumento delle nascite - discriminata sul lavoro, scoraggiata a proseguire gli studi, massaia ideale e, meglio ancora, massaia rurale ideale: «obbedire, badare alla casa, mettere al mondo figli e... portare le corna», come recita un’apprezzata battuta del Duce.
Ma si deve proprio a Benito Mussolini la creazione dell’OMNI - Opera Nazionale Maternità e Infanzia - alla scopo di tutelare madri e figli in difficoltà, e il continuo incoraggiamento affinché la donna sia considerata il centro della famiglia, regina della casa e dell’autarchia.
Per sfruttare il desiderio delle donne di identificarsi e di servire la comunità nazionale, il regime cerca dunque un difficile equilibrio tra modernizzazione ed emancipazione.
E mentre si creano nuovi tipi di organizzazione che consentono di soddisfare il desiderio di impegno pubblico delle donne, si reprimono le varie forme di solidarietà femminile ed i valori di libertà, individuale e politica, in precedenza promossi dalle associazioni femministe. Queste ultime, in particolare quelle di origine borghese, sebbene prive di una forte organizzazione o di un vasto consenso, sopravvivono per circa un decennio all’avvento di Mussolini.
Costrette a rinunciare alla battaglia per il suffragio femminile, dopo il 1925 le femministe di un tempo rivolgono il loro impegno al volontariato sociale o all’attivismo culturale, dando vita ad una nuova subcultura femminile di dimensioni nazionali. Un fenomeno definito “sano femminismo” da contrapporre al “vano femminismo”.
Come ha scritto la emancipazionista socialista Laura Cabrini Casartelli (1883-1932): “Il movimento delle donne non ha mai raggiunto una grande coscienza propria vivendo sempre un pò di vita riflessa”. Ciò lo trova impreparato alla contesa con l’onda alta della rivoluzione fascista. “Erano l’autentico amore per la Patria, un largo umanitarismo ed un vivo sentimento sociale - ha aggiunto la Casartelli - a spingere le donne a simpatizzare con il programma fascista di valorizzazione della vittoria, di esaltazione della guerra nazionale, di opposizione a uomini e a metodi”.
Per quanto diffidenti nei confronti dell’esaltazione della forza operata dal fascismo, le donne sono tuttavia attratte dal suo forte spirito di sacrificio. Inoltre, anche se non possono fare politica, esse compaiono anche nelle squadre punitive - ma si tratta di una presenza di breve periodo -.
Una interessante curiosità: nel 1921 l’ “Almanacco della donna italiana” di Silvia Bemporad - periodico pubblicato a Firenze dal 1920 al 1943 - registra i neonati gruppi femminili nazionali e fascisti. Venticinquemila nei vecchi gruppi (Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, Unione Donne Cattoliche ed altri gruppi socialisti) e solo poche centinaia iscritte ai gruppi fascisti.
Fino alla marcia su Roma del 28 ottobre 1922 le aderenti al movimento non sono più di qualche centinaia.
Tra le fasciste della prima ora ricordiamo alcune vecchie compagne di lotta del Mussolini socialista, come Margherita Sarfatti, Regina Terruzzi e Giselda Brebbia. Altre provengono dai ranghi dannunziani delle “fiumane”, come Elisa Majer Rizzioli, la fondatrice dei Fasci femminili, Angiola Moretti, segretaria dell'organizzazione dal 1927 al 1930, e Rachele Ferrari Del Latte.
14/6/2018

Leopoldo Pirelli: "il re della gomma".
Appassionato di vela, ha lavorato per cinquant’anni nell’azienda di famiglia: la Pirelli, una tra le principali industrie italiane.
Nato a Velate, in provincia di Milano, il 27 agosto del 1925, Leopoldo Pirelli era figlio di Alberto e nipote del senatore Giovanni Battista, fondatore del gruppo industriale.
Gestì la Pirelli fino ai primi anni Novanta quando abbandonò la guida dell’azienda, che venne affidata ad Alberto Pirelli prima e a Marco Tronchetti Provera dopo. E proprio con quest’ultimo è stata sposata la figlia di Leopoldo, Cecilia.
Leopoldo Pirelli, figura di spicco del mondo dell’impresa, ha svolto un ruolo altamente significativo per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Erede di una grande tradizione industriale, è stato protagonista dello sforzo di innovazione delle relazioni industriali e di internazionalizzazione dell’impresa italiana.
“Un imprenditore deve sempre cercare, con tutte le sue forze, di chiudere buoni bilanci. Se non ci riesce una volta, riprovare. Se non ci riesce più volte, andarsene. E se ci riesce non deve credersi un padreterno, ma uno che ha fatto il suo dovere”. È questa l’idea che ha ispirato fino alla morte Leopoldo Pirelli. Con Gianni Agnelli è stato simbolo del miracolo economico e bersaglio delle contestazioni dopo l’autunno caldo del 1969.
Cavaliere del lavoro dal 1977, “il re della gomma” si laurea al Politecnico di Milano nel 1950 in Ingegneria meccanica ed entra nell’azienda di famiglia nel ‘54 come consigliere: due anni dopo è nominato vice presidente e nel ‘65 presidente di Pirelli spa. Assunta nel 1957 la carica di socio accomandatario di Pirelli & C (la cosiddetta Pirellina, che sta a capo del gruppo) ne diventa presidente nel 1995. Appassionato di vela, tifoso milanista, è stato definito spesso “un calvinista con il culto della privacy”.
Schivo e poco mondano, due figli, Pirelli si circonda dell’amicizia di altre famiglie e protagonisti del “gotha” milanese: Enrico Cuccia, i Bonomi, i Falck, gli Orlando. Alla fine degli anni Sessanta è pioniere della globalizzazione con l’alleanza con Dunlop, fallita però qualche anno dopo. Negli anni Settanta è protagonista della riforma di Confindustria (di cui è membro a vita dal 1982) e a lui si deve l’introduzione della lettera agli azionisti e l’apertura alla piccola industria e ai giovani industriali.
All’inizio degli anni Novanta Leopoldo Pirelli tenta la scalata alla tedesca Continental cercando un partner strategico, ma l’operazione salta. Si prende ogni responsabilità della fallita scalata e nel ‘92 cede la guida operativa a Tronchetti Provera. Nel 1999 il suo ritiro definitivo (diventerà presidente onorario) con la rinuncia a tutte le cariche societarie.
È lui stesso a designare l’erede: “Marco - aggiunge poco prima della sua uscita di scena parlando di Tronchetti Provera - è certamente l’artefice della ripresa del nostro gruppo, ne è il leader: è molto intelligente, ha intuito e comando di uomini all’interno e senso delle relazioni all’esterno dell’azienda”.
Dopo il suo ritiro il gruppo cambia, e diventa protagonista delle tlc con l’acquisto di Telecom.
Leopoldo Pirelli si è spento il 23 gennaio del 2007, all’età di 81 anni, nella sua casa di Portofino.
Dopo quella di Enrico Cuccia e Gianni Agnelli, la scomparsa di Pirelli chiude definitivamente un capitolo della Storia, non soltanto industriale, dell’Italia.
12/6/2018

Falck: storia di una dinastia “di acciaio”.
La storia di una grande dinastia industriale che durante gli anni del boom economico ha dato vita ad un colosso della siderurgia a livello europeo, improntato al rigore e all’etica di un modello di capitalismo familiare e solidale.
La storia dei Falck è la storia di una delle più importanti “dinastie” industriali italiane.
Una famiglia di imprenditori dell’acciaio che nel dopoguerra è anche protagonista della vita politica italiana con la fondazione della Dc milanese, tenuta a battesimo nella casa di Enrico Falck. Di origini alsaziane, Giorgio Enrico Falck, già terza generazione di pionieri della siderurgia, mette insieme due ferriere e acquista il primo terreno alle porte di Milano agli inizi del secolo scorso.
È del 1906 la costituzione della Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde con l’apertura dello stabilimento di Sesto San Giovanni denominato “Unione”. Poco dopo parte la realizzazione del Villaggio Falck destinato ad abitazioni per i dipendenti.
Con gli anni la Falck costruisce e mette a disposizione dei lavoratori oltre duemila appartamenti, case di riposo, centri di dopolavoro e centri sportivi, oltre a colonie estive e biblioteche.
Intanto il complesso siderurgico decolla, e a breve gli si accompagna anche una catena di impianti idroelettrici destinati ad alimentare gli stabilimenti di Sesto.
Nel 1924 la Falck sbarca al sud Italia, e nel 1935 vengono fondate le Acciaierie Bolzano.
Nel secondo dopoguerra, i fondi del Piano Marshall permettono la ricostruzione degli impianti.
Nel 1963 sotto la presidenza di Giovanni Falck, figlio del fondatore, arriva la quotazione alla Borsa Valori di Milano.
Nel 1964, subito dopo la laurea alla Bocconi, il nipote Alberto entra nel settore amministrativo della società, per poi diventare membro dei Cda della capogruppo e delle principali partecipate. Nel 1971 la società è il principale gruppo siderurgico privato italiano, con una produzione annuale pari a circa l’8% dell’intero prodotto nazionale.
Nel novembre del 1980, nella difficile stagione degli “anni di piombo”, le Brigate Rosse uccidono barbaramente il direttore generale dello stabilimento, Manfredo Mazzanti.
Nel 1982 la presidenza passa ad Alberto Falck affiancato dal cugino vicepresidente Giorgio Enrico Falck, figlio di Giovanni. Ma la crisi della siderurgia mondiale ridisegna presto gli scenari complessivi.
Alberto Falck guida l’uscita del gruppo dal settore dell’acciaio con l’adesione, nel 1995, al piano europeo di chiusure di stabilimenti.
Giorgio Enrico Falck - esperto velista e noto alle cronache rosa per la separazione dall’attrice Rosanna Schiaffino - si oppone, vende le sue azioni, lascia la carica di amministratore delegato e si ritira a vita privata.
Nel 1996 tutti gli impianti di Sesto vengono smantellati. Le aree di proprietà della società vengono cedute nel dicembre del 2000.
Dal 2001 inizia l’attività di ristrutturazione e di riposizionamento della Falck nei settori dell’ambiente e dell’energia. Nel frattempo si assiste allo sfortunato tentativo di fusione con Montedison: nel febbraio 2001 infatti l’assemblea dei soci Montedison, a sorpresa, dice no alla fusione.
Attualmente la Falck si concentra su Actelios, nuova società del Gruppo che produce energia attraverso fonti rinnovabili, di cui Alberto Falck - deceduto nel 2003 in un tragico incidente stradale - è stato presidente.
12/6/2018

Pillole di Storia
Il delitto Matteotti
Ripercorriamo i momenti cruciali della vicenda del rapimento e dell'assassinio di Giacomo Matteotti (1885-1924): deputato socialista impegnato in prima linea nella denuncia dei crimini e delle violenze del fascismo, ucciso il 10 giugno del 1924.
Nato il 22 maggio del 1885 a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, Giacomo Matteotti si avvicina giovanissimo al socialismo, collaborando con il periodico “La lotta” e facendosi eleggere nel 1919 alla Camera in quota PSI. Esponente dell’area riformista legata a Filippo Turati, Matteotti denuncia più volte in Parlamento le violenze dei fascisti, arrivando a parlare di brogli all’indomani delle elezioni politiche del 1924, che consegnano la maggioranza assoluta al partito di Benito Mussolini.
Ma facciamo un passo indietro.
Il fascismo, ormai padrone delle piazze e del Governo, non tollera di essere ancora minoranza in Parlamento: ricorre quindi ad una legge liberticida, preparata da Giacomo Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
La “Legge Acerbo”, attribuendo la maggioranza assoluta alla lista che raccoglie il 25% dei voti, garantisce al fascismo mano libera anche alla Camera dei Deputati.
Il comportamento preelettorale dei partiti democratici favorisce i piani dei fascisti: questi accolgono nelle loro liste, il cosiddetto “listone”, anche esponenti di altri movimenti, indebolendo così gli avversari, mentre per quest’ultimo simulacro di competizione elettorale i vari gruppi politici dividono le loro forze.
Anche le liste socialiste sono due, quella unitaria di Turati e Treves, praticamente guidata da Giacomo Matteotti, e quella massimalista. Matteotti infatti si rifiuta di fare blocco con l’ala estrema del socialismo: quella che si è separata a Livorno nel 1921 e che ha preso il nome di Partito Comunista. Ma i fascisti non intendono affidare la loro sorte alla libera volontà dei cittadini.
Si vota dunque il 6 aprile 1924 in un clima di intimidazione e i risultati non smentiscono le previsioni. Sono eletti 374 candidati del listone, mentre l’opposizione, divisa, ne ottiene meno della metà.
Due mesi dopo, alla riapertura della Camera, una voce si leva per protestare contro gli abusi, le illegalità, le violenze, chiedendo la sospensione di quasi tutti i deputati eletti nel “listone”.
È quella di Giacomo Matteotti: “Molti sistemi sono stati impiegati per impedire la libera espressione della volontà popolare. Solo un piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto…Sentiamo tutto il male che all’Italia apporta il sistema della violenza…La tirannia determina la morte della nazione…”.
Ma intanto la tirannia ha già condannato a morte Matteotti.
Il 10 giugno del 1924 un’automobile si ferma accanto a lui, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, sulla strada che egli percorre per andare a Montecitorio. Cinque squadristi, guidati da Amerigo Dumini, lo inseguono lungo la scaletta che scende al fiume, lo stordiscono, lo trascinano in macchina, allontanandosi poi sulla via Flaminia.
Si sparge l’allarme: tre giorni dopo si parla di assassinio, la polizia finge di indagare. Il corpo straziato di Giacomo Matteotti è rinvenuto due mesi dopo, nella macchia della Quartarella, vicino a Riano, a ventitré chilometri da Roma.
Quando il delitto viene provato e denunciato, la pietà per la vittima si unisce all’indignazione verso i colpevoli e i mandanti. L’assassinio non è più l’opera brutale e spavalda dello squadrismo locale, ma un atto della politica del governo fascista.
Solamente in agosto - 21 agosto ’24 - dopo la scoperta e il riconoscimento del cadavere, vengono celebrati i funerali.
L’ultimo viaggio di Matteotti, per volontà del governo, è circondato dalla prudenza. La salma parte quasi di nascosto da Monterotondo verso Fratta Polesine, vicino a Rovigo, e lassù, nel suo paese natale, una grande folla accompagna Matteotti dal treno al cimitero.
Nel frattempo si apre ovunque, intorno al regime, un vuoto morale. Cadono le ultime illusioni di “normalizzazione”, e la frattura fra fascisti e antifascisti diventa incolmabile.
Ci si trova di fronte a un delitto di Stato.
9/6/2018

I padri della Costituzione: Enrico De Nicola.
Il 28 giugno 1946 - dopo che il referendum del 2 giugno aveva premiato i sostenitori della Repubblica - l’Assemblea Costituente ritenne opportuno designare come Capo dello Stato provvisorio una figura che fosse in grado di mediare tra le diverse anime del Paese e raccogliesse il maggior consenso possibile: Enrico De Nicola (1877-1959). Insigne giurista, brillante giornalista, egli è stato inoltre il primo Presidente della Repubblica Italiana.
Il ritratto di un grande protagonista della storia d’Italia.
Enrico De Nicola nasce a Napoli il 9 novembre del 1877. A soli 19 anni si laurea in Giurisprudenza sotto la guida di Enrico Pessina. Avvocato dal 1898, diventa assai presto uno dei più noti penalisti della città e del Paese.
Attivo anche nel campo giornalistico, dal 1895 è redattore per la rubrica quotidiana di vita giudiziaria del Don Marzio, di area crispina. Diventa consigliere comunale a Napoli nel 1907 con il sindaco Ferdinando Del Carretto, ed è poi eletto alla Camera dei Deputati nel marzo 1909 (XXIII legislatura), nel collegio di Afragola, essendo poi confermato nelle elezioni del 1913 (XXIV legislatura).
Vicino al gruppo giolittiano, viene nominato Sottosegretario di Stato per le colonie nel IV Governo Giolitti (1913-1914); diviene quindi Sottosegretario di Stato per il tesoro nel Governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando (gennaio- giugno 1919).
Nel dicembre del 1919 guida la lista democratico-costituzionale per le elezioni alla Camera dei Deputati nel collegio di Napoli. Diviene presidente della Giunta delle elezioni e poi, dopo le dimissioni di Vittorio Emanuele Orlando, il 26 giugno 1920 è eletto Presidente della Camera dei Deputati, su indicazione di Giolitti.
Durante la XXV legislatura il ruolo di De Nicola assume grande importanza per la riforma dei regolamenti parlamentari, che egli promuove in qualità anche di presidente della Giunta del regolamento. La riforma del 1920 adatta la struttura della Camera alla nuova realtà rappresentata dal sistema elettorale proporzionale e dai partiti di massa. In tale occasione, sono riformati profondamente gli organi della Camera, regolando il sistema delle Commissioni permanenti (fissate in numero di nove) e la disciplina dei Gruppi parlamentari.
Rieletto deputato nel maggio del 1921, è di nuovo Presidente della Camera per l’intera legislatura (1921-1924). Nel giugno 1921, De Nicola dovrebbe succedere a Giolitti alla guida del Governo, su proposta dello stesso anziano leader liberale, ma egli preferisce rinunciare, lasciando la strada aperta al Governo Bonomi.
Nel luglio del 1921 si impegna nelle trattative del cosiddetto “patto di pacificazione” tra socialisti e fascisti, poi firmato nel suo ufficio di Presidente della Camera il 3 agosto. Ma l’accordo si rivela inutile nel porre fine agli scontri. Nel 1922 sono ulteriormente modificati i regolamenti parlamentari, introducendo alcuni limiti al diritto di parola nel processo verbale e per l’illustrazione di ordini del giorno.
Anche con la crisi del Governo Bonomi (febbraio 1922) egli è in predicato per la Presidenza del Consiglio, ma una serie di dissidi impediscono il tentativo di De Nicola, aprendo la strada al Governo guidato da Luigi Facta (febbraio-ottobre 1922).
Il 16 novembre 1922 presiede la tumultuosa seduta della Camera durante la quale Mussolini, nel presentare il nuovo Governo, afferma che avrebbe potuto “fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”.
Come molti altri esponenti liberali, pur preferendo il ritorno al collegio elettorale uninominale, appoggia, quale misura eccezionale, la riforma elettorale maggioritaria nota come “legge Acerbo” (novembre 1923) ed accetta, con qualche esitazione, di candidarsi nel listone nazionale a Napoli.
Anche in seguito alle violenze e all’esacerbarsi degli scontri politici, si ritira di fatto dalla competizione elettorale pochi giorni prima delle elezioni dell’aprile 1924. Pur rieletto, egli non presta il giuramento richiesto per essere ammesso alle funzioni di deputato e, di conseguenza, non prende parte alle attività parlamentari. Nei mesi successivi De Nicola decide di appartarsi dalla vita politica attiva, per riprendere a tempo pieno l’attività professionale nel suo studio napoletano.
Nel 1927 fa parte della Commissione ministeriale per l’esame del progetto preliminare del nuovo codice penale. Nel marzo del 1929 è nominato senatore del Regno, ma partecipa ad una sola seduta del Senato per votare in favore dei Patti lateranensi (maggio 1929), salvo poi non prendere più parte ai lavori parlamentari. È comunque componente della Commissione per il giudizio dell’Alta Corte di Giustizia (1929-1934), quindi della Commissione degli affari interni e della giustizia (1939-1940).
È presidente del Consiglio dell’ordine (all’epoca Commissione reale) degli avvocati di Napoli dal 1929 al 1934.
Con la caduta del fascismo riprende lentamente ad intervenire nella vita pubblica. In un articolo su Il Mattino del 25 agosto 1943 saluta “il ritorno alle guarentigie costituzionali”; nel 1944 propone l’istituto della luogotenenza, affidata al principe Umberto, come soluzione provvisoria della questione istituzionale. È poi nominato membro della Consulta nazionale (settembre 1945), dove diventa presidente della Commissione giustizia.
All’indomani del referendum istituzionale in favore della Repubblica (2 giugno 1946), i principali partiti si accordano sul suo nome e, nella seduta del 28 giugno 1946, l’Assemblea Costituente elegge De Nicola Capo provvisorio dello Stato, con 396 voti su 501 votanti: entra in carica il 1º luglio.
De Nicola esercita il suo mandato nei primi difficili anni della Repubblica, stabilendo una serie di prassi costituzionali destinate ad essere seguite anche successivamente, quali quelle in materia di consultazioni in caso di crisi di governo. Egli svolge il suo compito con riservatezza e austerità. Durante la crisi di governo del maggio 1947 cerca di evitare la fine dell’unità nazionale antifascista tra democristiani, da un lato, e socialisti e comunisti, dall’altro, tentando di promuovere un nuovo esecutivo unitario guidato da una prestigiosa figura quale Vittorio Emanuele Orlando o Francesco Saverio Nitti.
A tale prospettiva si oppone De Gasperi, che forma pertanto il suo quarto Governo il 31 maggio 1947, sostenuto solo dai partiti centristi (DC, PSLI, PRI e PLI). Il 25 giugno 1947 De Nicola si dimette - ufficialmente per motivi di salute - ma è rieletto alla carica il giorno dopo, al primo scrutinio, con 405 voti su 431 votanti.
Il 27 dicembre 1947 promulga la nuova Costituzione dell’Italia repubblicana. A norma della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio 1948 De Nicola assume il titolo di Presidente della Repubblica.
Dopo le elezioni del 18 aprile 1948 e l’ascesa alla Presidenza della Repubblica di Luigi Einaudi (12 maggio 1948), De Nicola diventa senatore di diritto, e a vita, quale ex Presidente della Repubblica. Al Senato entra nel gruppo misto, ed è membro della Commissione giustizia.
Il 28 aprile 1951 è eletto Presidente del Senato, ma si dimette dalla carica nel giugno 1952.
Dal marzo al giugno 1953 è presidente del gruppo misto. Durante la II legislatura repubblicana egli è ancora presidente del gruppo misto del Senato (giugno 1953-febbraio 1955) e componente della Commissione giustizia.
Il 3 dicembre 1955 è nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, e nel corso della prima riunione del nuovo organo (23 gennaio 1956) i giudici costituzionali lo eleggono alla Presidenza.
Si dimette anche da questa carica nel marzo 1957, in polemica verso il Governo, in occasione di un conflitto con l’Alta Corte della Regione siciliana. Riprende così il suo posto al Senato.
Durante la III legislatura, è ancora iscritto al gruppo misto e membro della Commissione giustizia, nonché presidente della Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge costituzionale concernenti la durata e la composizione del Senato della Repubblica.
Si spegne nella sua casa di Torre del Greco, vicino Napoli, il 1 ottobre del 1959.
7/6/2018

I padri della Costituzione: Giovanni Leone.
Era il 15 giugno del 1978 - sono trascorsi 40 anni - quando il Presidente della Repubblica Leone, all’indomani dell’assassinio di Aldo Moro e degli esiti referendari relativi al finanziamento pubblico dei partiti, verificato il venir meno dell’appoggio del suo schieramento, a soli sei mesi dal termine del mandato rassegnava le proprie dimissioni. “Ho servito il Paese con correttezza costituzionale e con dignità morale”, stigmatizzava nel messaggio televisivo agli italiani.
Ma chi era Giovanni Leone (1908-2001): ripercorriamo insieme la storia del sesto Presidente della Repubblica Italiana. Giurista di fama mondiale e penalista tra i più apprezzati d’Italia, tre volte Presidente della Camera e due volte Presidente del Consiglio. Il ritratto di uno dei padri della Costituzione.
Giovanni Leone nasce a Napoli il 3 novembre del 1908.
A soli 21 anni si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, dove l’anno successivo consegue anche la laurea in Scienze politiche e sociali.
Dopo gli studi si dedica all’attività forense e a quella accademica. Formatosi alla scuola di Eduardo Massari, Leone esercita la professione di avvocato, collaborando inizialmente allo studio di Enrico De Nicola, due figure che eserciteranno grande influenza sulla sua formazione umana e intellettuale, oltre che tecnico-giuridica.
In breve tempo diventa uno dei protagonisti del foro napoletano e dopo aver conseguito la libera docenza in Diritto e Procedura penale, vince nel 1936 il concorso per professore ordinario ed è chiamato ad insegnare prima a Messina, poi a Bari e infine a Napoli. Presidente del gruppo italiano della “Association Internationale de Droit Pénal”, pubblica in quegli anni un numero rilevantissimo di opere di Diritto penale, nelle quali l’apporto scientifico assume valenza decisamente innovativa per i profili sostanziali e ancor più per quelli processuali. Nello stesso periodo contribuisce alla redazione del Codice della navigazione.
Durante la guerra diventa magistrato del Tribunale militare di Napoli, con il grado di tenente colonnello. Dopo l’armistizio si adopera per la liberazione di prigionieri e disertori, per proteggerli da gravi rappresaglie o dalla prigionia tedesca.
Si iscrive alla Democrazia Cristiana, e nel 1945 ne diventa segretario per la città di Napoli. Al I Congresso Nazionale del partito, nel 1946, sostiene la tesi della neutralità rispetto al referendum istituzionale.
Il 2 giugno 1946 è eletto deputato all’Assemblea Costituente. Per le note competenze giuridiche entra a far parte della Commissione per la Costituzione, incaricata di redigere il testo del progetto e del Comitato dei diciotto, responsabile del coordinamento delle proposte presentate.
Membro della II Sottocommissione per l’organizzazione costituzionale dello Stato e relatore per i titoli riguardanti la magistratura e la Corte costituzionale, Leone fornisce un contributo rilevante all’elaborazione della Carta fondamentale, sia in termini strettamente tecnici, sia attraverso un atteggiamento costante di ricerca dei punti di incontro tra le diverse posizioni politiche.
Dal 1948 al 1963 è eletto ininterrottamente alla Camera dei Deputati fino alla nomina a senatore a vita. Piuttosto estraneo alla lotta tra le correnti all’interno della DC, Leone continua ad affiancare all’impegno politico l’esercizio della professione di avvocato e la docenza universitaria.
Nel 1950 assume la carica di Vicepresidente della Camera ed è riconfermato in tale incarico nel 1953. Dopo l’elezione di Giovanni Gronchi alla Presidenza della Repubblica, il 10 maggio 1955 è eletto Presidente della Camera. Riconfermato Presidente nel 1958 e nel 1963, permane quindi nella carica per otto anni consecutivi fino al giugno 1963, dimostrando una notevole capacità di governo delle dinamiche parlamentari ed un grande rispetto delle regole del confronto democratico.
Dopo le elezioni politiche del 1963 le trattative per la formazione del nuovo Governo si arenano a causa delle profonde divergenze tra democristiani e socialisti sui contenuti programmatici del futuro Esecutivo. La mancata ratifica da parte del Partito socialista dell’accordo faticosamente raggiunto tra i principali esponenti democristiani, repubblicani, socialdemocratici e socialisti, rende necessaria una tregua tra le forze politiche, che induce Moro a rimettere il mandato di formare il Governo nelle mani del Capo dello Stato.
Segni affida a Leone l’incarico di formare un nuovo Governo con un compito definito nei contenuti e nei tempi. Leone costituisce un Esecutivo monocolore, formato cioè da soli democristiani, definito “governo-ponte”, che ottiene in Parlamento la fiducia della DC e conta sull’astensione dei socialisti, dei socialdemocratici e dei repubblicani.
Nel novembre dello stesso anno, dopo l’approvazione dei bilanci, ritenendo esaurito il compito che il Governo si era prefisso all’atto della costituzione e avendo assicurato alle forze politiche l’auspicata tregua, Leone rassegna le dimissioni.
Il prestigio personale di Leone, che non conta sul sostegno di una corrente precisa all’interno del suo partito, ne esce rafforzato al punto che nel 1964 è il candidato ufficiale della DC alla Presidenza della Repubblica e nel 1967 il Presidente Saragat lo nomina senatore a vita per altissimi meriti in campo scientifico e sociale.
La capacità di coniugare la propria appartenenza politica con le ragioni istituzionali è alla base della sua seconda esperienza di governo.
Nel giugno 1968 viene a crearsi un nuovo momento di impasse tra le forze politiche. Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat affida a Leone l’incarico di formare un Governo che, in attesa di un chiarimento tra i partiti di centro-sinistra, porti a compimento i provvedimenti più urgenti per il Paese. Leone costituisce il suo secondo Governo monocolore, che resta in carica fino alle dimissioni presentate a novembre dello stesso anno.
Va anche ricordata l’importante attività di mediazione che Leone è chiamato a svolgere durante l’iter di approvazione parlamentare della legge sul divorzio (1970). Attraverso l’approvazione di emendamenti che contribuiscono a definire un istituto giuridico più equilibrato, Leone riesce a varare un’ipotesi di compromesso tra le posizioni più rigide del fronte antidivorzista e quello divorzista.
Continua la carriera universitaria e svolge un’intensa attività forense fino all’elezione alla Presidenza della Repubblica, avvenuta il 24 dicembre 1971.
Dopo il tramonto della candidatura di Fanfani, al ventitreesimo scrutinio, con 518 voti su 996, Leone è eletto Capo dello Stato, raccogliendo il consenso dei democratici cristiani, dei socialdemocratici, dei liberali e dei repubblicani. In questa occasione non mancano alcune polemiche generate dalla probabilità che sul suo nome siano confluiti voti espressi da esponenti del Movimento sociale.
Durante il mandato presidenziale fronteggia passaggi particolarmente delicati della vita istituzionale, politica e sociale del Paese: dalla necessità di ricorrere per la prima volta allo scioglimento anticipato delle Camere nel 1972 al rapimento di Aldo Moro nel 1978.
Dopo i primi anni di mandato si diffondono insistenti contestazioni al suo operato e a quello di persone a lui vicine in relazione al presunto coinvolgimento in episodi di corruzione. L’apposita Commissione inquirente dimostrerà la totale estraneità del Presidente ai fatti contestati.
Il Presidente Leone, all’indomani dell’assassinio di Aldo Moro e degli esiti referendari relativi al finanziamento pubblico dei partiti, verificato il venir meno dell’appoggio del suo partito, la sera del 15 giugno 1978 - a soli sei mesi dal termine del mandato - rassegna le dimissioni. Nel messaggio televisivo agli italiani ribadisce di aver “servito il Paese con correttezza costituzionale e con dignità morale”.
Dopo un primo periodo di vita strettamente privata, Leone torna ad assicurare un contributo di particolare rilievo al tema della riforma dei codici e dell’amministrazione della giustizia, attraverso gli studi giuridici e la partecipazione ai lavori parlamentari in qualità di senatore a vita.
Infine non manca di battersi attraverso interviste e scritti, oltre che in sede giudiziaria, per vedere pienamente affermato il riconoscimento della correttezza degli atti compiuti da Capo dello Stato.
Si spegne a Roma il 9 novembre del 2001, all’età di 93 anni.
6/6/2018

Giovanni Spadolini
La vita e la carriera di Giovanni Spadolini (1925-1994): il ritratto di un autorevole protagonista della storia politica e culturale italiana del secondo Novecento.
Giovanni Spadolini nasce a Firenze il 21 giugno del 1925. Nel 1947 si laurea in Giurisprudenza nell’ateneo fiorentino e intraprende subito un’intensa attività giornalistica. Nel 1948 inizia a collaborare con “Il Messaggero” e l’anno successivo con “Il Mondo” di Mario Pannunzio.
Nel 1950 è incaricato dell’insegnamento di Storia moderna II presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, titolare di quella che dieci anni più tardi diventerà la prima cattedra in Italia di Storia contemporanea.
Ha diretto il “Resto del Carlino” fra il 1955 e il 1968 e il “Corriere della Sera”, dal 1968 e al
1972, negli anni difficili attraversati dalla contestazione e dalla strategia della tensione. È poi la volta della collaborazione fissa a “La Stampa” di Torino, durata fino alla morte. Fin dagli
anni Cinquanta ha diretto e animato la rivista culturale “Nuova Antologia”, rivista che ha “salvato” nel 1978 affidandola alla Fondazione appositamente costituita, che ne cura la continuità, la
qualità e l’indipendenza.
Nel 1972 Spadolini viene eletto senatore a Milano, come indipendente nelle file del Partito repubblicano italiano di Ugo La Malfa.
È stato presidente della Commissione Pubblica Istruzione e Belle arti di palazzo Madama, ministro-costituente per i Beni culturali e ambientali nel dicembre 1974, nel IV governo Moro.
Il dicastero fu da lui costituito attraverso un decreto legge, causa il grave degrado nel quale si trovava il patrimonio nazionale, e fu concepito nell’ottica di “sburocratizzare tutto ciò che era cultura” e di creare quella che Spadolini chiamava, con un certo orgoglio voltairiano, “la Repubblica dei saggi”. Dopo questa importante esperienza nel 1979 diviene ministro della Pubblica Istruzione, nel V governo Andreotti e pochi mesi dopo la morte di Ugo La Malfa è eletto segretario nazionale del Partito Repubblicano. Con lui il partito superò per la prima volta nel 1983 il 5% dei consensi elettorali, raggiungendo il massimo storico.
Nel 1981 è chiamato dal Presidente Sandro Pertini, dopo lo scandalo della P2 e nel pieno della crisi economica e morale, alla guida del primo governo laico - cioè non guidato da un esponente della Democrazia Cristiana - dalla proclamazione della Repubblica. I suoi due governi coincidono con i successi nella lotta al terrorismo, all’inflazione, alla corruzione e con il rafforzamento dei legami internazionali atlantici ed europeisti dell’Italia.
Nei successivi governi presieduti da Bettino Craxi, Spadolini è ministro della Difesa dal 1983 al 1986. Nel luglio 1987 viene eletto al primo scrutinio presidente del Senato, con suffragio quasi plebiscitario e ricopre questa carica per l’intera durata della decima e undicesima legislatura: dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992 e dal 24 aprile 1992 al 14 aprile 1994, poche settimane prima della morte avvenuta a Roma il 4 agosto del 1994.
Per i suoi alti meriti culturali il 2 maggio 1991 all’indomani della scomparsa di Cesare
Merzagora, era stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Dalla Presidenza di Palazzo Madama Spadolini segue con attenzione gli sviluppi della crisi italiana e indica la necessità di affrontare il tema delle riforme attraverso un percorso realistico a
piccoli passi, con un lavoro di ricerca paziente delle “cose possibili senza illusioni palingenetiche”, rivolte a razionalizzare e modernizzare il sistema politico nato dalla Costituzione.
Questo intento riformatore era già emerso nel 1982 quando Spadolini era riuscito a superare una crisi di governo partendo da un accordo sulle riforme istituzionali, codificato nel noto “decalogo” che comprendeva alcuni importanti provvedimenti: il nuovo ordinamento dei ministeri accanto a quello della Presidenza, un ridisegno delle autonomie locali, la correzione degli usi distorti dei referendum, la modifica della disciplina del voto segreto in Parlamento, una corsia preferenziale per i progetti governativi, nuovi meccanismi per il rispetto della norma costituzionale sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Intuisce inoltre la grave crisi attraversata dai partiti politici e la necessità di autoriformarsi.
Il suo impegno politico si intreccia sempre con quello intellettuale. Come presidente del Senato, così come nelle vesti di presidente del Consiglio, Spadolini studioso di Storia, intellettuale arrivato alla politica nella seconda fase della sua vita, ha testimoniato con l’inesauribile impegno il nesso inscindibile fra politica e cultura.
Accademico dei Lincei, ha ricoperto numerose cariche culturali presiedendo l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (dal 1976 fino alla morte), la Giunta centrale degli studi storici, l’Istituto italiano di studi storici di Benedetto Croce, la Società toscana per la storia del Risorgimento.
Uomo di autentica cultura, storico, giornalista, politico, ha sviluppato il suo pensiero e la sua
attività in più direzioni, tenendo insieme nel suo itinerario intellettuale e in tutto il suo operato il rigore dello storico, l’intuito del politico, la sintesi del giornalista, le qualità dello
scrittore.
È autore di oltre sessanta opere storiche e politiche, di cui alcune fondamentali, riguardanti soprattutto i rapporti fra Stato e Chiesa, la storia culturale e politica nazionale e quella del
pensiero laico in Italia.
Fra le opere più significative è da ricordare “Gli uomini che fecero l’Italia”, giunta dopo innumerevoli ristampe, nel 1993, all’edizione definitiva pubblicata da Longanesi in un unico volume di quasi mille pagine. Si tratta di una vasta galleria di ritratti che comprende centododici grandi personaggi dal Settecento al Novecento.
È “il compendio della mia vita”, ha scritto nell’aprile del 1993, in occasione dell’uscita di quella edizione riordinata e ristrutturata in via definitiva. Un libro autobiografico, riassuntivo di una vita di studi e di impegno civile.
6/6/2018

Pillole di Storia
“D-Day” : lo sbarco in Normandia.
Il 6 giugno del 1944 aveva inizio lo sbarco in Normandia: Operazione Overlord. Nome in codice dello sbarco militare più imponente della Storia che, oltre a determinare le sorti della Seconda guerra mondiale, avrebbe influito sulla geografia politica dell'Europa fino al crollo del Muro di Berlino.
Dicembre 1941. Nonostante i proclami della propaganda nazista, il Natale di quell'anno segna l'inizio della disfatta. Il Führer, sicuro di vincere subito, aveva ordinato divise invernali solo per un quinto dei soldati. Ma né l'Inghilterra né la Russia si sono piegate; gli Stati Uniti, invece, avanzano. Dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour, è guerra totale. L'8 dicembre 1941 il Führer dichiara guerra a Roosevelt ritenendo un bluff il potenziale bellico americano.
Novembre 1943: Roosvelt, Stalin e Churchill si incontrano a Teheran per decidere l’attacco alla Germania e il suo destino. Si stabilisce di aprire ad un secondo fronte nella Francia settentrionale sorprendendo i nazisti con lo sbarco in Normandia, il 6 giugno 1944, guidato da Eisenhower - nome in codice operazione Overlord - . 5.000 navi, 11.000 aerei e 176.000 soldati USA compiono lo sbarco più famoso della Storia. Per il Terzo Reich è un colpo mortale; lo stesso Hitler sembra vacillare. È depresso, insonne, costretto a vivere in bunker sotterranei. Il suo medico di fiducia riferisce di un paziente ipocondriaco, che dopo il fallito attentato ai suoi danni nel luglio del ’44 degenera in uno stato di profonda paranoia. Nel febbraio del '45, mentre il Terzo Reich è ridotto ad un cumulo di macerie dai bombardamenti alleati, Hitler vaneggia e medita una controffensiva. Il suo ultimo ordine è quello di combattere fino all'ultimo uomo: l'ultima leva è composta di anziani e bambini, ma non basta. Pochi giorni prima di togliersi la vita Hitler dichiara "Ero l’ultima speranza per l’Europa". Il 30 aprile 1945 mentre i sovietici entrano per primi a Berlino, Hitler si suicida.
Il 7 maggio 1945 una Germania materialmente e moralmente distrutta firma la resa senza condizioni: la guerra in Europa è finita.
Ricordato come il «D-Day», lo sbarco in Normandia ha ispirato negli anni un'ampia produzione pubblicistica e cinematografica.
Tra i film più recenti va ricordato “Salvate il soldato Ryan” (1998) del regista Steven Spielberg, premiato con quattro Oscar (Migliore regia, Migliore fotografia, Miglior montaggio, Miglior sonoro) e apprezzato dalla critica per aver raccontato con crudo realismo la fase più drammatica dello sbarco.
5/6/2018

Giuseppe Saragat: il quinto Presidente.
La figura di Giuseppe Saragat (1898-1988) - di cui tra pochi giorni ricorre il trentennale della scomparsa - è indissolubilmente legata alla nascita della Repubblica e alla emanazione della Carta Costituzionale, essendo stato il primo Presidente dell’Assemblea Costituente, eletto il 25 giugno 1946, immediatamente dopo il referendum che fece dell’Italia una Repubblica. Come quinto Capo dello Stato, il III Municipio di Roma gli ha intitolato un tratto del “Viadotto dei Presidenti”.
Giuseppe Saragat nasce a Torino il 19 settembre del 1898. Partecipa come volontario alla Prima guerra mondiale. Successivamente si laurea in Scienze economiche e commerciali e lavora nell’Ufficio Studi della Banca commerciale italiana, prima a Torino e poi a Milano.
Nel 1922 si iscrive al Partito socialista unitario, avviandosi giovanissimo ad un impegno politico che lo porterà negli anni seguenti su posizioni decisamente antifasciste. Estraneo alle lotte tra le correnti che lacerano il partito nell’immediato dopoguerra, Saragat si schiera al fianco dei riformisti ed entra a far parte della direzione del partito nel 1926. Alla fine di quello stesso anno, con il consolidarsi del regime fascista, decide di espatriare.
Inizialmente si stabilisce a Vienna, poi, a causa degli effetti della crisi economica è costretto a trasferirsi a Parigi, dove intensifica l’attività politica.
Gli anni trascorsi all’estero assumono un valore decisivo nella formazione politica di Saragat, che diventa uno degli esponenti di punta del socialismo italiano. Convinto sostenitore dell’operazione di riunificazione con il troncone massimalista guidato da Pietro Nenni, negli anni Trenta dedica la propria riflessione alla definizione della cosiddetta “autonomia socialista”.
Inizialmente ostile all’intesa con i comunisti, Saragat si convince successivamente dell’inevitabilità della collaborazione con il Partito comunista in funzione antifascista e sigla, insieme a Nenni, nel 1934 il primo Patto d’unità d’azione.
All’indomani del “patto di non aggressione” siglato tra Germania e Unione Sovietica nel 1939 tornano in primo piano le divisioni tra Saragat e Nenni, che si vede costretto a lasciare tutte le cariche del partito. L’aggressione tedesca contro l’Unione Sovietica permette ai due dirigenti socialisti di ritrovare un accordo e di siglare un nuovo Patto di unità d’azione con il gruppo di “Giustizia e libertà” e con i comunisti, che durerà per tutto il periodo della guerra e della Resistenza.
Rientrato in Italia subito dopo la caduta del fascismo, Saragat partecipa alla difesa di Roma, ma viene arrestato e imprigionato insieme ad altri antifascisti.
Riesce ad evadere dal carcere e alla liberazione di Roma, nel 1944, entra a far parte come Ministro senza portafoglio del primo Governo dell’Italia liberata, guidato da Ivanoe Bonomi.
Nel marzo del 1945 è nominato ambasciatore d’Italia a Parigi, carica che ricopre fino all’anno dopo, quando chiede di tornare in Italia per poter riprendere la propria attività politica.
Il 25 giugno 1946 è eletto Presidente dell’Assemblea Costituente e fa parte insieme a Ivanoe Bonomi della delegazione italiana, guidata dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che partecipa ai lavori della Conferenza di pace che si apre a luglio dello stesso anno a Parigi.
Al Congresso del Partito socialista dell’aprile 1946 il rapporto tra socialisti e comunisti torna ad essere nuovamente terreno di scontro tra la maggioranza del partito guidata da Nenni, Basso e Morandi, schierata a favore del consolidamento dell’alleanza con il PCI e di una scelta neutralista sul piano internazionale, e i gruppi di Critica sociale e il movimento giovanile guidati da Saragat, contrari ad ogni collaborazione con i comunisti.
Durante i lavori del XXV Congresso del PSIUP del gennaio 1947 Saragat interviene annunciando l’avvenuto distacco della minoranza, che si riunisce a Palazzo Barberini e fonda un partito moderato e riformista: il Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI), più tardi denominato Partito socialista democratico italiano (PSDI). Alla chiusura del Congresso Saragat rassegna le dimissioni da Presidente dell’Assemblea Costituente ed assume la segreteria politica del nuovo partito.
L’adesione al PSLI di un numero consistente di parlamentari socialisti e la scelta di posizioni filoatlantiche in politica estera favoriscono la rottura del tripartito DC-PSI-PCI e la formazione a maggio del 1947, dopo un governo monocolore democristiano, del IV Governo De Gasperi, di cui entrano a far parte repubblicani, liberali e socialdemocratici, inaugurando la formula del quadripartito e la politica centrista. Saragat è nominato Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Eletto alla Camera dei Deputati ininterrottamente dalla I alla IV legislatura, nel V Governo De Gasperi ricopre nuovamente la carica di Vicepresidente del Consiglio dei ministri oltre a quella di Ministro della marina mercantile. Dal 1949 al 1954 torna alla segreteria del Partito socialista democratico ed è ancora Vicepresidente del Consiglio dei ministri dal 1954 al 1957, nei Governi presieduti da Scelba e da Segni.
Nel 1956 la crisi del movimento comunista, conseguente al XX congresso del PCUS ed ai fatti d’Ungheria, sembra rendere possibile la riunificazione dei due partiti socialisti. L’incontro di Pralognan tra Saragat e Nenni nel 1956 non ha effetti immediati, ma riannoda i fili del dialogo e crea le premesse per il successivo ingresso dei socialisti nell’area di governo.
Con la nascita dei primi Governi di centro-sinistra, I e II Gabinetto Moro, Saragat e Nenni sono insieme al Governo, il primo in veste di Ministro degli esteri e il secondo di Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
La comune partecipazione al Governo facilita ulteriormente l’avvicinamento tra i due partiti e favorisce l’elezione di Saragat alla Presidenza della Repubblica e la riunificazione dei socialisti nel 1966.
Dopo le dimissioni anticipate del Presidente della Repubblica Antonio Segni, il 28 dicembre 1964 il Parlamento in seduta comune elegge Giuseppe Saragat quinto Presidente della Repubblica, con 646 voti su 963. La candidatura di Saragat è inizialmente sostenuta dalla Democrazia Cristiana e dai partiti laici in opposizione a quella di Nenni, candidato dei socialisti e dei comunisti. Al ventunesimo scrutinio Nenni ritira la propria candidatura, consentendo una larghissima confluenza su Saragat, che ottiene anche i voti dei parlamentari comunisti.
Oltre che per la difesa dei valori dell’antifascismo e della Resistenza, il settennato presidenziale di Saragat si caratterizza per lo sforzo di consolidamento delle istituzioni democratiche, attraverso l’allargamento della base di consenso in Parlamento e nel Paese. In questa ottica torna di attualità, secondo Saragat, il progetto di unificazione socialista, che si realizza nel 1966 ma non trova conferma nei risultati delle elezioni politiche del 1968, conducendo quindi ad un’ultima definitiva scissione dei socialisti.
Concluso il settennato presidenziale, Saragat entra a far parte del Senato in qualità di senatore a vita. Nel 1975 torna nuovamente a guidare il Partito socialista democratico rivestendo la carica di presidente, poi di segretario e di nuovo di presidente a vita del partito.
Si spegne a Roma l’11 giugno del 1988, alla soglia dei 90 anni.
4/6/2018


Cronache - in pillole - dalla Casa Bianca
50 anni fa, Bob Kennedy: un sogno - infranto - americano.
Lyndon B. Johnson, vecchio uomo politico formatosi durante il periodo roosveltiano del New Deal, dopo l’assassinio di John Kennedy, in qualità di vicepresidente assume immediatamente il potere presidenziale secondo le regole costituzionali. Sulla scia del suo predecessore decide di aumentare gli interventi in difesa del Vietnam dall’aggressione comunista, ma il forte coinvolgimento degli Stati Uniti non porta il successo militare sperato. Il governo viene isolato mentre la nazione si spacca. Il 31 marzo 1968 Johnson ordina la cessazione dei bombardamenti sul Nord Vietnam e annuncia il ritiro della sua candidatura alle prossime elezioni. Nel Partito democratico si profila dunque la candidatura del fratello di John Kennedy, il senatore Bob. Egli, dopo essere stato una figura di primo piano accanto al presidente assassinato, ha serie possibilità di successo, ed avanza un programma di rinnovamento interno e di pace nel Vietnam. Ma il 5 giugno 1968 a Los Angeles, dopo un comizio, come suo fratello e il pastore battista Martin Luther King, viene assassinato senza che si faccia luce sui mandanti politici. La sua morte aprirà la strada al repubblicano Richard Nixon.
4/6/2018

Franz Kafka: la "metamorfosi" dello scrittore.
Introspezione psicologica e speculazione filosofica sull’esistenza umana sono le due principali direttrici che riassumono l’opera di uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema: Franz Kafka (1883-1924).
Franz Kafka nacque a Praga il 3 luglio del 1883 dal commerciante ebreo Hermann Kafka e da Julie Löwy, nella casa chiamata Zum Turm (nell’odierna U radnice). L’edificio, quasi completamente distrutto, è stato ricostruito e della struttura originale è rimasto solo il grande portone - una lapide con busto all’angolo ricorda che qui è nato lo scrittore -. Ebbe tre sorelle più giovani, Elli, Valli e Ottla, scomparse tutte nei campi di concentramento nazisti.
Dal 1889 al 1901 Kafka studiò nella Deutsche Knabenschule e successivamente nel ginnasio cittadino; dal 1901 al 1906 frequentò l’Università Tedesca di Praga, dove si laureò in Giurisprudenza. Il primo testo letterario conservato si data negli anni 1904-1905 (Descrizione di una battaglia). Nel 1907 cominciò a lavorare presso le "Assicurazioni Generali", per passare nell’anno successivo all’"Istituto di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il Regno di Boemia", di cui rimarrà dipendente fino al 1922, quando andrà in pensione per malattia.
Le sue amicizie in questo periodo comprendono Oskar Baum, Feliz Weltsch e Max Brod; quest’ultimo sarà suo amico per tutta la vita e dopo la morte di Kafka si renderà benemerito per aver salvato e pubblicato tutto il lascito inedito dello scrittore.
Fra il 1910 e il 1912 Kafka si occupò sempre più intensivamente di cultura ebraica, e strinse amicizia con Jizchak Löwy, a capo di una piccola compagnia di artisti ebrei. Nel 1910 iniziò inoltre i Diari; nel 1911 cominciò il romanzo Il disperso (rimasto incompiuto, pubblicato postumo da Brod con il titolo America). In questi anni scrisse molti testi brevi, apparsi dapprima nella rivista "Hyperion" (1908), infine in una edizione a parte con il titolo Meditazioni, apparsa nel 1913 presso l’editore Rowohlt. Il 13 agosto del 1912 conobbe Felice Bauer, la donna più importante della sua vita, di cui sarà fidanzato (con una lunga interruzione) fino al dicembre 1917. Negli ultimi mesi del 1912 scrisse i due importanti racconti La condanna e La metamorfosi; quest’ultimo venne pubblicato nel 1915. Subito dopo una prima rottura del fidanzamento con Felice, nell’agosto 1914, iniziò il romanzo Il processo, di cui però interromperà la stesura all’inizio del 1915.
Nel frattempo scrive Nella colonia penale, di cui darà una lettura pubblica nel novembre 1916. Fino all’aprile del 1917 Kafka scrisse la serie di racconti che apparirà in volume nel 1919 con il titolo Un medico di campagna. All’inizio del 1917 cominciò a studiare l’ebraico.
Nella notte fra il 9 e il 10 agosto 1917, Kafka accusò una grave emottisi; il 4 settembre gli venne diagnosticata la tubercolosi polmonare. Conseguentemente, il fidanzamento con Felice venne rotto definitivamente nel dicembre dello stesso anno. Nel 1919 si fidanzò con Julie Wohryzeck, proveniente da una famiglia di operai ebrei di origine ceca; anche questo fidanzamento verrà interrotto nel 1920.
Ai primi del 1920, durante una permanenza in un sanatorio di Merano, iniziò la corrispondenza con la giornalista ceca Milena Jesenská, unica donna non ebrea nella vita di Kafka, moglie di Ernst Pollak e prima traduttrice in ceco di numerosi racconti kafkiani. È a lei che Kafka affidò nel 1921 i propri diari, consentendone così la sopravvivenza.
Nel 1922 Kafka soggiornò per tre settimane nel sanatorio di Spindelmühle; a febbraio iniziò il suo terzo romanzo Il castello, progetto abbandonato nell’agosto dello stesso anno per un peggioramento delle condizioni di salute. Nel 1922 iniziò anche il ciclo degli ultimi grandi racconti: Primo dolore, Un digiunatore, Indagini di un cane.
All’inizio del 1923 intensificò il suo studio dell’ebraico e progettò un viaggio in Palestina cui pensava da molti anni. In luglio-agosto, in un soggiorno a Müritz sul mar baltico, conobbe la giovane Dora Diamant, ebrea cassidica di origine polacca; con lei, nel settembre 1923, Kafka finalmente lasciò Praga e si trasferì a Berlino. L’inverno berlinese del 1923-1924, particolarmente severo, insieme alle condizioni economiche rese drammatiche dall’inflazione, pregiudicarono definitivamente la sua salute; nel frattempo però Kafka sembrò aver raggiunto una condizione di vita cui aveva sempre aspirato, e trascorse le giornate nella scrittura e nello studio intensivo della lingua e della cultura ebraica.
Alla fine di febbraio del ‘24 le sue condizioni peggiorarono al punto che Max Brod lo riaccompagnò a Praga, dove scrisse Giuseppina la cantante o il popolo dei topi.
Gli venne diagnosticata una laringite tubercolare che gli impedì di parlare - restano i suoi ultimi biglietti di conversazione - e alla fine anche di inghiottire. In queste condizioni il 19 aprile venne trasferito alla casa di cura di Kierling, presso Klosterneuburg, dove negli ultimi giorni corresse le bozze dell’ultima raccolta - che da uno dei racconti prenderà il titolo Un digiunatore - che apparirà presso l’editore "Die Schmiede" subito dopo la sua morte.
Franz Kafka si spense il 3 giugno del 1924; al letto di morte erano presenti Dora Diamant e il giovane amico e medico Robert Klopstock. L’11 giugno venne sepolto nel cimitero ebraico di Praga-Straschnitz.
Nel suo testamento, Kafka chiese all’amico Max Brod di dare alle fiamme tutti i manoscritti inediti e di impedire nuove edizioni di quelli editi. Brod tuttavia rifiutò di dare corso al desiderio dell’amico e negli anni seguenti pubblicò i tre romanzi, tutti racconti e frammenti, i diari e gran parte delle lettere.
Già negli anni Trenta, ma in forma sempre più imponente nei decenni successivi, la grandezza letteraria di Kafka venne riconosciuta in tutta Europa; la sua influenza sulla cultura del Novecento è incalcolabile.
3/6/2018

Arnaldo Pomodoro: l’essenzialità delle forme.
Scultore di rilievo mondiale, fratello del celebre Giò Pomodoro, le sue forme geometriche - per lo più sfere di bronzo - campeggiano su strade e piazze delle principali città di tutto il mondo.
Arnaldo Pomodoro nasce a Morciano di Romagna, il 23 giugno del 1926.
Dopo gli studi di Architettura, Arnaldo, come suo fratello Giò, esordisce come disegnatore, decoratore ed artigiano del metallo. Crea monili, pezzi astratti di oreficeria, piccole sculture in oro e argento che lasciano intravedere valide premesse per una nuova scultura, lontana dalle forme tradizionali. Notevole, comunque, è il debito di riconoscenza dell'artista nei confronti dei maestri del primo Novecento ed in particolare Paul Klee e Costantin Brancusi.
Per il suo passaggio all'arte plastica fondamentale è il trasferimento, nel 1954, a Milano dove comincia a frequentare l'ambiente artistico di Brera: in particolare Lucio Fontana, Enrico Baj, Umberto Milani, Emilio Scanavino, Gianni Dova e Ugo Mulas. Proprio a partire dal 1954 Pomodoro inizia ad esporre in numerose gallerie d'arte in Italia e all'estero.
Le prime sculture, a metà degli anni Cinquanta, sono rilievi modellati nel ferro, stagno, piombo, argento, cemento e bronzo. L'uso di questi materiali inediti testimonia la ricerca e la volontà di Pomodoro di sperimentare nuovi mezzi formali ed espressivi.
Dalla frontalità del rilievo si passa, negli anni Settanta, alla complessità spaziale e materica della forma a tutto tondo. L'ispirazione di questo periodo deriva dalle forme perfette di Brancusi. La perfezione della forma provoca in lui, anche sotto l'influenza del mondo tecnologico e dell'action painting di Jackson Pollok, una pulsione distruttiva: la forma perfetta viene fatta a pezzi.
Nel 1960 Pomodoro aderisce insieme a Perilli, Turcato, Dorazio e Giò Pomodoro al Gruppo «Continuità» (1961-62), uno dei più importanti gruppi nella ricerca astratta tra materia e segno.
Da qui in poi ha trovato una propria cifra nell'equilibrio delle geometrie esterne e dei «paesaggi» interni delle opere monumentali, tra cui le Colonne e le Sfere.
La sua scultura è dominata da un rigoroso "ésprit de géometrie". Ogni forma pertanto è ridotta all'essenzialità volumetrica della sfera, del cubo, del cilindro, del cono, del parallelepipedo e di altri solidi euclidei nettamente tagliati in schiere o segmenti di schiere rettilinee o circolari, paragonabili alle rapide successioni delle note ribattute in una composizione musicale o ad ingranaggi di misteriosi macchinari nascosti nell'interno di massicci contenitori (globi, colonne continue, cubi, dischi) e resi parzialmente visibili dagli squarci e dai tagli che rompono le lisce superfici di questi ultimi.
Dalla capacità di associare, in perfetta coerenza di stile, tali crepitanti microstrutture a una monumentalità palese anche nelle grandissime dimensioni dei suoi bronzi, nasce l'originalità delle creazioni di Pomodoro, per le quali lo spazio esterno non esiste e tutto si svolge in quello quasi viscerale racchiuso da levigati involucri oppure nitidissimi volumi su piatti supporti verticali, come nelle stupende porte scenografiche per l'Oedipus rex di Stranvinski rappresentato a Siena nel 1988, nelle quali, ingigantita e trasferita in un'aura mitica, vediamo riaffiorare la suggestività dell'etrusca Tomba dei rilievi di Cerveteri.
Le sue opere sono presenti in grandi piazze (Milano, Copenaghen, Brisbane), di fronte al Trinity College dell’Università di Dublino, al Mills College in California, nel Department of Water and Power di Los Angeles, nel Cortile della Pigna dei Musei Vaticani e nelle maggiori raccolte pubbliche del mondo.
Nel 1991 è stato collocato davanti al Palazzo della Gioventù a Mosca il "Disco Solare", dono della Presidenza del Consiglio all’Unione Sovietica, e nel 1992 è stata installata un’opera di grandi dimensioni "Papyrus" nei giardini del nuovo Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni a Darmstadt, in Germania.
Nel 1995 ha realizzato per incarico del Comune di Rimini una scultura in memoria di Federico Fellini; nel 1996 è stata collocata nel piazzale delle Nazioni Unite a New York l’opera "Sfera con sfera" del diametro di 3,30 metri, e nel 1998 ha ricevuto l’incarico di realizzare il portale del Duomo di Cefalù.
Nel 2000 ha esposto le sue sculture nel parco della Reggia di Caserta e nel 2004 è stata collocata a Roma, nel quartiere dell’Eur, la sua opera Novecento, un’imponente torre-obelisco spiraliforme.
Impegnato anche come scenografo teatrale, Arnaldo Pomodoro nel 2014 ha curato la scenografia dell'Orestea di Eschilo, rappresentata al Teatro greco di Siracusa.
Questo grande “Maestro” della scultura contemporanea vive e lavora a Milano.
30/5/2018


Un profilo di Federico Zeri: un intellettuale - eccentrico - controcorrente.
Federico Zeri (1921-1998): il ritratto di un grande critico, nel ventennale della scomparsa.
Nato a Roma il 12 agosto del 1921, Federico Zeri, laureatosi in Storia dell’arte nella Capitale con Pietro Toesca (1944), arricchisce la sua formazione anche attraverso i rapporti con Frederick Antal e Roberto Longhi.
Funzionario dell'amministrazione delle Antichità e belle arti dal 1948 al ‘52, ricopre il ruolo di visiting professor alla Harvard University (Cambridge, Massachusetts) e alla Columbia University (New York). Dal 1975 al 1984 è curatore del J.P. Getty Museum di Malibu e, dal 1993, vicepresidente del Consiglio nazionale dei beni culturali. Nel 1995 viene nominato membro associato straniero dell'Académie des beaux-arts de l'Institut de France.
Profondo conoscitore della pittura italiana dal XIII al XVIII secolo, Zeri affronta con metodo storico-filologico indagini su eventi di rilievo della storia artistica così come su fatti e personaggi minori o periferici, dedicando vari studi alla contestualizzazione e alla ricostituzione del corpus di artisti poco noti.
In “Pittura e controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gaeta” (1957) esamina i rapporti tra la produzione artistica e la cultura post-tridentina, mentre le sue convinzioni filologiche emergono in “Due dipinti, la filologia e un nome”. “Il Maestro delle tavole Barberini” (1961) e in “La percezione visiva dell'Italia e degli italiani” (1989). Applica il suo metodo di indagine, fondato sul rapporto diretto con l'opera, nella stesura di cataloghi di collezioni pubbliche e private, come: “La Galleria Spada in Roma” (1954), “La Galleria Pallavicini in Roma” (1959), “Italian paintings. A catalogue of the collection of the Metropolitan Museum of Art” (4 voll., in collaborazione con E.E. Gardner, 1971-86), “Census of pre-nineteenth-century Italian paintings in North American collections” (in collaborazione con B.B. Fredericksen, 1972), “Italian paintings in the Walters art gallery” (1976).
Tra i cataloghi da lui curati si ricordano anche quelli della Pinacoteca di Brera e della Narodna Galerija di Lubiana. Fonda inoltre la rivista Antologia di belle arti (1977), e cura dal 1983 la seconda e la terza parte della “Storia dell'arte italiana”, pubblicata da Einaudi.
Numerose sono le raccolte di saggi e contributi - dai quali spesso emerge il carattere polemico dei suoi interventi - dedicate a questioni storico-artistiche ma anche a problemi di varia attualità.
Per ricordarne alcune: “Diari di lavoro” (2 voll., 1971-72); “Mai di traverso” (1982) e “L'inchiostro variopinto” (1985), in parte ripubblicati in “Il cannocchiale del critico” (1993); “Dietro l'immagine” (1987, a cura di Ludovica Ripa di Meana); “Giorno per giorno nella pittura” (4 voll., 1988-94); “Orto aperto” (1990).
Zeri inoltre pubblica varie conversazioni e colloqui autobiografici, tra i quali “Confesso che ho sbagliato. Ricordi autobiografici” (in collaborazione con P. Mauriès, 1995).
L’autorevole critico e storico dell’arte si spegne nella sua villa a Mentana, vicino Roma - lasciata in eredità con annessa biblioteca e fototeca all’Università di Bologna affinché divenisse un Centro Studi, ma attualmente in vendita a causa di problemi di manutenzione -, il 5 ottobre del 1998, all’età di 77 anni.
28/5/2018


